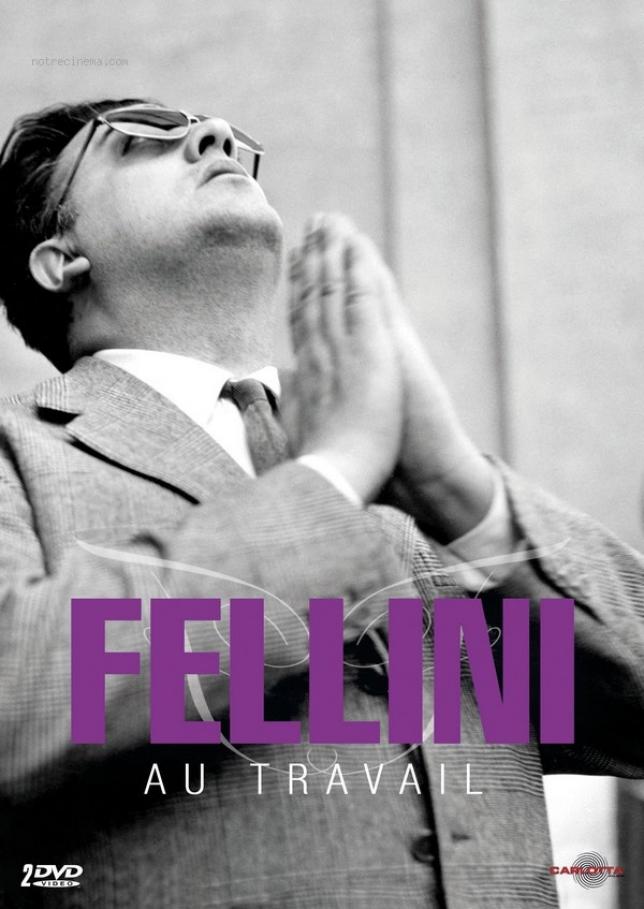A conclusione della rassegna Trame e intrecci (mediatecanapoli.it/articoli/…">mediatecanapoli.it/articoli/…">mediatecanapoli.it/articoli/…...), riportiamo le schede critiche elaborate per la presentazione di alcuni dei film proiettati e contenenti il profilo di alcuni maestri del cinema a cui abbiamo reso omaggio (Bergman, Fellini, De Oliveira):
A CIASCUNO IL SUO di Elio Petri (1967)
L'AVVENTURA DI UN SOLDATO di Nino Manfredi (1962)
IL BELL'ANTONIO di Mauro Bolognini (1960)
BERGMAN: BERGMAN 100 - LA VITA, I SEGRETI, IL GENIO di Jane Magnusson (2018), DONNE IN ATTESA (1952), LEZIONE D'AMORE (1954), UN'ESTATE D'AMORE (1951), SORRISI DI UNA NOTTE D'ESTATE (1955), KARIN'S FACE (1983)
IL CONFORMISTA di Bernardo Bertolucci (1970)
LA COTTA di Ermanno Olmi (1967)
CRONACA FAMILIARE di Valerio Zurlini (1962)
DE OLIVEIRA: ANIKI BOBO (1942), PORTO DELLA MIA INFANZIA (2001)
Nonostante i grandi riconoscimenti ottenuti - il Premio Oscar per Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, la Palma d'oro per La classe operaia va in paradiso e il premio per la migliore sceneggiatura proprio per A ciascuno il suo -, Elio Petri resta un regista sottostimato e frettolosamente collocato nella categoria dei cineasti politici, ciò che non restituisce appieno la ricchezza del suo cinema. Un cinema barocco in cui la creatività prevale sul rigore ideologico delle intenzioni. In cui una regia espressionista che utilizza gli espedienti del grottesco e gli insegnamenti brechtiani si espande in visioni oniriche e kafkiane, e utilizza l'artificio per meglio esplorare la realtà e le aberrazioni del potere.
Ma in ogni caso, il suo fu un cinema impegnato. E l' engagement comincia proprio con A ciascuno il suo che peraltro segna pure l'inizio del fortunato sodalizio artistico fra Elio Petri, lo sceneggiatore Ugo Pirro e, soprattutto, Gian Maria Volonté.
Petri vedeva intorno a sé, come molti altri registi dell'epoca come Rosi, Pasolini, Bellocchio i segnali di una regressione paurosa verso la barbarie: il comportamento della classe dirigente; la distruzione di un'Italia contadina per creare una finta Italia industriale e americana; la trasformazione delle bellissime città in dormitori e garage aperte all'insaziabile avidità della speculazione edilizia; il trionfo della filosofia del profitto. Avvertiva un malessere, che non era solo esistenziale, assoluto, ma legato alle condizioni storiche in cui si viveva.
Il libro di Sciascia del '66 accese in lui la scintilla: il clima politico dell'Italia meridionale vi era dipinto con chiarezza, le forze in gioco, Chiesa e DC, venivano chiamate per nome. Il ruolo dell'intellettuale, secondo Petri, era delineato con intelligenza e ironia, un ruolo astratto, per così dire e in un certo senso castrato: in una civiltà industriale gli intellettuali sono i castrati, staccati come sono dalla realtà, obbligati a vivere i problemi della società da falsari, attraverso la mediazione della cultura. Ma proprio la figura dell'intellettuale, il professore Laurana, era quello che gli interessava di più, più della mafia, distaccato dalla realtà, umanamente, politicamente e anche sessualmente isolato.
Professore in un liceo di Palermo, Paolo Laurana non è convinto che l'uccisione di due uomini, il farmacista Manno e il dottor Roscio, sia avvenuta per motivi d'onore come le indagini vogliono far credere. Aiutato dalla vedova di uno dei due maggiorenti, comincia una propria indagine.
A ciascuno il suo anticipa l'esplicito impegno e la straordinaria complessità politica e concettuale che saranno propri dei film successivi, la critica a una società che non vede, non sente e non parla, una società corrotta e ipocrita, una società silente, protetta oppure impaurita dal potere trasversale e a volte criminale della Chiesa.
Ma come fare per penetrare dentro questo mondo, omertoso, oscuro? Petri lo fa con una narrazione complessa, ramificata e oscura come quella Sicilia in cui si svolge la vicenda, con un montaggio costantemente pronto a cambiare ritmo facendosi improvvisamente serrato, e soprattutto con una originale messa in scena dominata in particolare: dall'uso continuo degli zoom, quasi a voler far coincidere lo sguardo dello spettatore con quello del protagonista o scoprire i lati nascosti dei personaggi, da un montaggio frenetico, da primissimi piani e da una macchina da presa mobilissima.
In fondo, l'Italia raccontata dal regista non è tanto diversa da quella di oggi, rappresentata da una cultura tradizionale senza identità, senza presente e senza capacità comunicativa. La feroce critica di Petri alla classe politica, alla sessualità repressa, alle diseguaglianze sociali, è oggi più attuale che mai, visto il populismo dilagante e la violenza verbale e fisica che porta con sé.
L'AVVENTURA DI UN SOLDATO di Nino Manfredi (1962)
Fa parte di un film a episodi (L'amore difficile del 1962).
La formula del film a episodi era molto sviluppata negli anni '60. Serviva a far conoscere registi esordienti senza troppi rischi per chi lo produceva, anzi costituendo per il produttore un vero affare.
Gli aspiranti registi, il più delle volte, si daranno molto da fare: avranno già messo da parte il soggetto che li stimola di più, si saranno assicurati un attore di successo senza spendere troppo, loro stessi chiederanno poco per la regia.
L'amore difficile non sfugge a questa regola. I registi esordienti hanno preso come soggetto altrettanti racconti sull'amore (uno di Ercole Patti, uno di Moravia, uno di Mario Soldati e uno di Calvino) e adottato il modulo narrativo della commedia.
Di questi quattro episodi ovviamente quello che si segnala è l'episodio di Manfredi che vedremo, esordio folgorante dietro la macchina da presa (poche altre furono poi le sue regie: Per Grazia ricevuta del '72, e Nudo di donna dell '81). Il film come detto si ispira a un delizioso racconto di Italo Calvino che fa parte della raccolta Gli amori difficili.
Nello scompartimento di un treno viaggiano cinque persone: una donna con la figlioletta, un vecchietto, un giovane militare e, accanto a lui, una giovane vedova appena salita sul treno. Siamo d' estate e fa molto caldo. Il soldato comincia a toccare, in modo discreto, ma via via in modo sempre più insistente...
Poco più di un aneddoto, una storia esilissima, con un parlato estremamente rarefatto ridotto a una dozzina di battutte, eppure il film è di grande forza e coinvolgimento, il cui fascino è nell'uso fortemente significativo del mezzo cinematografico, nell'uso della macchina da presa, nel non detto, e capace di raccontare nel chiuso spazio di un vagone ferroviario turbamenti e desideri e rivelarsi al tempo stesso indagine comportamentale su di un esemplare tipico di Don Giovanni all'italiana.
Con un finale quasi chapliniano.
IL BELL'ANTONIO di Mauro Bolognini (1960)
Mauro Bolognini si è molto spesso ispirato alla letteratura, trasponendo sullo schermo tantissimi autori del Novecento tra cui Vasco Pratolini (Metello), Alberto Moravia (Agostino, Gli indifferenti - serie televisiva -, La villa del venerdì, La giornata balorda) e ora Vitaliano. Brancati che peraltro è stato uno scrittore che ha avuto un certo ruolo nel cinema italiano scrivendo numerosi film, tra cui il più importante è sicuramente Viaggio In Italia di Roberto Rossellini. Il film Il Bell'Antonio è del 1960 che è stato un anno fatidico per il cinema italiano nel corso del quale uscirono in sala altri capolavori pluripremiati, La dolce vita di Federico Fellini, Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, L'avventura di Antonioni e La ciociara di De Sica: una stagione davvero irripetibile e Bolognini ne ha fatto parte a pieno titolo.
Bolognini è stato, come già ho avuto modo dire, un regista particolarmente attento alla coerenza formale e alla precisione stilistica ma anche allo scavo psicologico e alla dialettica dei conflitti sociali e dotato di un acuto senso dell'immagine, di grande abiltà nel ricreare le atmosfere del passato, e con una certa predilezione per le storie passionali dalle forti connotazioni melodrammatiche.
Decisivo fu l'incontro con Pasolini che, prima ancora di esordire con Accattone, fu soggettista e sceneggiatore dei suoi primi film come La notte brava, 1959, e La giornata balorda, 1960, e anche di questo che ci apprestiamo a vedere, Il Bell'Antonio.
Qui Pasolini affronta un tema, gli italiani e la sessualità, al quale dedicherà qualche anno più tardi lui stesso un documentario: Comizi d'amore del 1964.
In cui mostrerà bene che il rapporto tra gli italiani e il sesso cambia secondo le classi sociali, le regioni, e naturalmente l'appartenenza di genere. Nel film Il bell'Antonio invece l'attenzione è concentrata su un sola regione, la Sicilia e un'unica classe sociale, l'alta borghesia, in cui il matrimonio non è che una questione di affari, una combinazione tra genitori per ottenere vantaggi economici dall'unione dei loro figli, e dove l'amore non ha ragione d'essere.
Il matrimonio coincide con l'entrata nel mondo del lavoro e la fine degli anni di studio e degli ozi dorati, gli anni delle scappatelle e dissolutezze il cui solo scopo sembrava essere il sesso libero. E ovviamente le cose sono differenti a seconda che si tratti di maschi o di femmine. Gli uomini costruiscono la propria reputazione a seconda delle conquiste fatte. Più numerose sono maggiori saranno il prestigio e l'invidia degli altri maschi. Laddove invece le donne sono solo delle promesse spose sottoposte al futuro marito. Vivono in un bozzolo e nella più completa ignoranza delle cose di sesso. Mentre l'uomo si dedica agli stravizi prima del matrimonio, la donna aspetta che le venga scelto il marito che dovrà servire. Figurarsi in un contesto del genere come possa essere considerata un'anomalia sessuale, se non come una piaga, e come al contrario venga venerata la “santa erezione”. Insomma un rapporto uomo-donna, le cui contraddizioni scoppieranno violentemente con l'arrivo del '68 e che porteranno a forti cambiamenti, oggi di nuovo messi in discussione.
Il bell'Antonio è proprio un rampollo della buona società catanese. Ritornato a casa dopo un soggiorno di studi a Roma rimane colpito dalla bellezza di Barbara, figlia di un notaio, con la quale i genitori combinano il matrimonio. Ma Antonio nasconde un segreto: è impotente.
Se il romanzo di Brancati pubblicato nel '49 è il ritratto, attraverso il personaggio di Antonio, di un'epoca, il fascismo, ritratto irriverente e spesso comico, un perfido schiaffo al machismo vigoroso del ventennio nero in chiave sicula, con pagine di raffinata ironia, il film di Bolognini si sposta su un registro di commedia amara, dalle note liriche e malinconiche o meglio oscillante tra la commedia dissonante e il dramma di costume senza essere né pienamente comico, né pienamente drammatico. In realtà è una miscela assai originale, ora ironica e caustica ora toccante, un mélange di toni perfettamente resi da una messa in scena che da una sequenza all'altra si fa sia realista che formalista. E Bolognini concentra lo sguardo sulla psicologia e sulle contraddizioni tutte interne dei personaggi e soprattutto su quella del protagonista che sembra volersi ribellare allo stato delle cose della società, ma non ne ha la forza.
Un lavoro di scavo nelle profondità della crisi, culturale e umana, di una generazione incatenata alle consuetudini e ai riti di una sacralità inviolabile come quella del rapporto uomo-donna, le cui contraddizioni scoppieranno violentemente con l'arrivo del '68 e che porteranno a forti cambiamenti, oggi di nuovo messi in discussione.
Il film ebbe grande successo dappertutto al punto che Mastroianni racconta nella sua autobiografia un aneddoto: “Uno o due anni dopo l'uscita del film, il Brasile o l'Argentina – non mi ricordo – comprò dagli Stati Uniti un vecchio incrociatore da guerra, che però non voleva saperne di funzionare: così lo soprannominarono El bel Antonio”.
BERGMAN
L'omaggio a Bergman apre la nostra rassegna annuale, che quest'anno abbiamo chiamato Trame e Intrecci, la quale si compone di altri importanti omaggi nei confronti di autori scomparsi (Olmi e Vittorio Taviani e Manoel de Oliveira), di film documentari che raccontano il cinema (Cinema al quadrato, il cinema che si racconta), di film ispirati alla letteratura nell'Italia degli anni '60 (Felici incontri. Cinema e letteratura nell'Italia degli anni '60).
Ma veniamo a Bergman. Una piccola premessa: ho letto di recente un intervento critico di Olivier Assayas. “Ci si potrebbe chiedere che cosa abbia da dirci oggi l'opera di Bergman. Ma si potrebbe anche ribaltare la domanda e chiedersi che cosa di noi ci dice il nostro rapporto con il suo cinema.
I suoi quaranta film non hanno mai cessato di essere visti e ciascuno di noi potrebbe tracciare la propria gerarchia, il proprio ordinamento, dentro questa filmografia così abbondante e multipla, ognuno vi troverebbe il capolavoro in grado di accordarsi con la propria sensibilità.”
Ma non è con un film di Bergman che partiremo, piuttosto con un film su Bergman: il recente documentario, girato proprio in vista del centenario della sua nascita, Bergman 100 - La vita, i segreti, il genio (2018) di Jane Magnusson -, il cui titolo inglese recita Bergman: A Year in A Life. Infatti si focalizza su un anno particolare nella vita e carriera del maestro, quel 1957 in cui realizzò Il posto delle fragole e Il settimo sigillo, ma realizzò anche quattro importanti regie teatrali, trasmissioni televisive e radiofoniche. Un documentario che nel raccontare la grandezza del genio non ne nasconde i lati oscuri (l'adesione al nazismo, la tirannia esercitata nei confronti di chi lavorava con lui, o l'ambiguità dei rapporti familiari, la disattenzione nei rapporti familiari, nei rapporti con le sue donne, numerosissime, con i suoi figli) e che risente dell'ambivalenza del sentimento nutrito dal suo paese nei suoi confronti, fatto di devozione (il monumento nazionale da venerare) ma anche di diffidenza e talvolta di indifferenza.
A ogni modo, facendo perno su questo documentario abbiamo scelto quattro film antecedenti al 1957, che appartengono a quella stagione della sua vita (Bergman non è ancora quarantenne) fatta di entusiasmi, di frenesia amorosa e lavorativa.
I titoli selezionati sono: Un'estate d'amore (1951), tra quelli che Bergman più amava (“lo scrissi col cuore”, dirà in diverse inetrviste), Donne in attesa (1952), Una lezione d'amore (1954) e Sorrisi di una notte d'estate (1955), il film che lo impose all'attenzione mondiale. Come vedete la parola estate ricorre due volte, poi verrà l'inverno, che sarà la fonte della sua ricerca in un'altra stagione della sua vita.
Questi film prefigurano già i grandi temi del maestro (l'inafferrabilità della giovinezza, simboleggiata dalla parola estate che ricorre spesso nella filmografia del regista – in fondo la breve estate svedese non è che la vita dell'uomo; la inaffidabilità dei ricordi che si corrompono e che noi idealizziamo; l'incombere del male-castigo, vale a dire la morte; la radiografia dei rapporti tra gli uomini e le donne, le illusioni, i trucchi, le sopraffazioni che si annidano nei rapporti coniugali; il tema della solitudine) e rivelano la sua attitudine a indagare in profondità i moti dell'animo umano, sia pure qui con toni lievi e (soprattutto in riferimento agli ultimi tre citati) dentro i canoni della commedia. Si tratta - con la sola eccezione di Sorrisi di una notte d'estate, che, come già detto, rivelò Bergman al pubblico mondiale e riscontrò un notevole apprezzamento della critica – di opere che non goderono del giusto riconoscimento che avrebbero meritato e che in seguito gli venne tributato. Di opere in cui, quella visione pessimista della vita, propria della sua opera e soprattutto dei suoi capolavori successivi, sembra qui stemperata, seppur sempre intrisa di un senso malinconico dell'esistenza, dalla vivacità delle situazioni messe in scena, dalla dirompente grazia e densità pregnante dei dialoghi (che racchiudono sempre grandi verità o piccole verità o verità inessenziali, ma sono sempre molto briosi e divertenti), dalla forza vitale e dal carattere delle donne, le vere protagoniste di questi film.
Un Bergman meno conosciuto, forse, ma che rivela già nei suoi tratti di elegante raffinatezza e lirismo la piena padronanza delle sue possibilità espressive.
Completa l'omaggio un cortometraggio di molto successivo, Karin's Face, del 1984, ritratto (in senso letterale) della madre.
BERGMAN: DONNE IN ATTESA (1952)
Nel corso di questa seconda serata dedicata al maestro svedese assisteremo al progressivo avvicinamento di Bergman alla commedia.
Film del 1952, Donne in attesa, appartiene, come già Un'estate d'amore, visto la settimana scorsa, alla produzione giovanile di Bergman, quella che parzialmente abbiamo cercato di restituire con questo nostro programma.
Quattro donne, le protagoniste del film come di moltissime altre opere dell'autore svedese, molto sensibile alle pieghe più nascoste dell'animo femminile, si ritrovano in una casa in riva al lago e aspettano i loro mariti (tra loro fratelli). Siamo in estate, la breve estate svedese così ricorrente oltre che nei titoli anche come ambientazione dei film di questo periodo. (L'estate che simboleggia la giovinezza, ma ancora di più la brevità della vita). Nell'attesa le quattro donne si raccontano le difficoltà, le incomprensioni, i fallimenti della loro vita coniugale a una a una. Man mano che si procede dal primo al quarto racconto si assiste, come dicevo all'inizio, a un progressivo affievolimento del dramma, che poco alla volta si fa commedia. Un procedimento diverso dunque dalla consuetudine narrativa che vede il dramma svilupparsi da una situazione iniziale di serenità se non di gioia.
Costruito quasi come un film a episodi l'autore analizza con grande finezza la coppia e il gioco amoroso riflettendo su sentimenti e problemi anche diversi come le illusioni della giovinezza, la solitudine, la fedeltà, il disgusto dell'altro, la gelosia, le convenzioni sociali, le difficoltà della comunicazione, gli istanti magici che non durano, il tempo che se ne va ed è irrimediabilmente perduto...
Temi e riflessioni che, come già detto, saranno propri di Bergman lungo tutta la sua carriera. Qui però li affronta con un tono dolce-amaro e Donne in attesa ci lascia nel finale un'impressione ambigua poiché, senza essere del tutto ottimista, non si tinge troppo di scuro. Ma, ovviamente, ognuno di voi ne trarrà l'impressione più aderente alla propria sensibilità.
BERGMAN: LEZIONE D'AMORE (1954)
Nell'introdurre il film precedente, Donne in attesa, dicevo che nel corso di questa seconda serata dedicata a Bergman assisteremo al progressivo avvicinamento di Bergman alla commedia. Ecco , in questo secondo film della serata siamo proprio dentro la commedia.
Chi ha visto Donne in attesa ricorderà l'ultimo dei racconti delle donne riunite in attesa dei propri mariti e che in quest'attesa si raccontano le proprie vicende coniugali, quello in cui moglie e marito rimangono bloccati nell'ascensore.
Ebbene, Lezione d'amore è una sorta di dilatazione proprio di questo episodio ( peraltro gli interpreti, Gunnar Bjornstrand ed Eva Dahlbeck sono gli stessi e interpretano lo stesso ruolo, quello cioè di marito e moglie.) I quali formano una coppia di coniugi sull'orlo del divorzio, che si ritrovano a fare un viaggio insieme, e la cui vicenda ci viene raccontata con una serie di flashback.
Una commedia romantica che sembra quasi fare a gara con la grande tradizione della commedia hollywoodiana, con i suoi ritmi (talvolta addirittura da slapstick) e la sua drammaturgia, la sua scrittura (perfino gli attori richiamano i divi hollywoodiani, Gunnar Bijornstrand, Gray Grant e Eva Dahlbeck, Mirna Loy).
Già dalla prima sequenza, ancora sui titoli di testa, un carillon ci mostra una marionetta donna tra due marionette uomini e una voce fuori campo che ci avverte: “Questo film è una commedia che potrebbe diventare una tragedia. Ma finisce bene, perciò è una commedia. Non l'autore, non i suoi personaggi, ma è la vita con i suoi trucchi e le sue complicazioni che impartisce questa lezione.”
Già da questa prima sequenza siamo situati all'interno del marivaudage , l'intreccio d'amore elegante e raffinato.
Come eleganti e raffinati sono i dialoghi, sempre molto intelligenti, e come la messa in scena, caratterizzata da una predilezione per il piano sequenza, cioè la ripresa in continuità senza tagli di montaggio, affinché gli attori possano recitare nella durata effettiva richiesta dal dialogo.
E tuttavia anche qui, come in tutte le sue commedie, affiorano sempre i temi cari al maestro svedese: la gioventù smarrita senza ideali, oppure la vecchiaia e il sentimento della morte che incalza.
Ma, ripeto, è sul versante del comico e della leggerezza che si dipana il racconto.
BERGMAN: UN'ESTATE D'AMORE (1951)
Film del 1951, Bergman non ancora trentenne. E' un film sulla stagione giovanile. Estate, parola ricorrente (Sorrisi di una notte d'estate), simboleggia appunto la giovinezza, ma ancora di più la brevità della vita. E il film è la rievocazione di un'estate lontanamente perduta. Il ricordo di una stagione dell'amore, di un posto dell'amore, ove ristorarsi per il resto della vita. E quindi anche un film sul ricordare, sulla corruttibilità del ricordo e sull'idealizzazione che se ne fa.
François Truffaut, grande ammiratore del cineasta svedese, descrisse il film come “Il film delle nostre vacanze, dei nostri vent'anni, dei primi amori”.
Dichiarò Bergman: “Un'estate d'amore fa parte della mia propria carne. Io lo preferisco per ragioni di carattere personale. Ho fatto Il settimo sigillo con il cervello, Un'estate d'amore con il cuore. Per la prima volta avevo l'impressione di lavorare in un modo del tutto personale, d'aver realizzato un film che nessun altro avrebbe potuto rifare dopo di me”.
Un'estate d'amore può essere letto come una risposta per immagini all'interrogativo: come rappresentare l'intimità, la cosa sentimentale? Marie (Maj – Britt Nilsson, una delle prime muse di Bergman) ritrova il diaro del giovane Henrik che racconta il loro idillio di gioventù. In sovrimpressione il viso dell'adolescente compare sul libro. Questo diario riapre le porte di un amore vissuto chiuse da tredici anni.
Si parla di struttura a flasback a proposito di questo film. Ma si tratta piuttosto di una danza delle reminiscenze. Quale la differenza? Il flashback procede piano piano con una certa pianificazione, mentre la reminiscenza irrompe a nostra insaputa con una irresistibile violenza. Mentre il flashback è un metodo, la reminiscenza è lo splendore sorprendente del passato nell'istante presente. Il viso di Henrik su quello di Marie è la prima di queste intrusioni grazie alla quale l'immagine offre ai nostri sguardi questa dolce violazione di ciò che è intimo. Questa intimità muta Bergman la raggiunge per la prima volta grazie a una semplice inquadratura sullo sguardo di Marie. Da questo semplice contro-campo sul suo sguardo, da questo grande piano sull'occhio truccato di Maria , in questo preciso istante, lo spettatore comprende che Marie non sta soltanto per guardare un oggetto qualsiasi, ma che qualcosa dal passato è tornata a visitarla e l'obbliga a ricordarsi; noi sappiamo, poiché questo dettaglio dell'occhio dura qualche secondo di troppo, che questa persona, Marie, non è più lì ma dentro un altrove che appartiene solo a lei.
Jean-Luc Godard, quando era critico ai Cahiers du cinéma scrisse nel gennaio del 1958: "Nella storia del cinema ci sono cinque o sei film che si amano di cui si potrebbe scrivere la critica usando solo queste parole: Il più bello dei film. Perché non c'è più bell'elogio di questo. E un'estate d'amore e il più bello dei film.”
BERGMAN: SORRISI DI UNA NOTTE D'ESTATE (1955), KARIN'S FACE (1983)
E concludiamo l'omaggio a Bergman con due preziosi film, un cortometraggio, Karin' face del 1983, pressoché sconosciuto, ma di una struggente bellezza e il film che ha reso celebre in tutto il mondo il cineasta svedese, Sorrisi di una notte d'estate (1955).
Il cortometraggio, Karin's Face, del 1983, è una successione di foto accompagnate dalla melodia delle note di un piano. A Bergman basta poco per raccontare una storia e nondimeno farci emozionare. Apparentemente semplice, apparentemente privo di ogni simbologia bergmaniana, anche questo breve film invece racchiude temi, stilemi e ossessioni del maestro svedese.
Sorrisi di una notte d'estate (1955), un'altra grande commedia di Ingmar Bergman.
Il film ottenne uno dei premi più sibillini del festival di Cannes: il premio per “l'umorismo poetico”. Qualunque sia il significato di questa espressione, il film diede finalmente fama internazionale al suo autore.
Come si può notare compare ancora una volta nel titolo la parola estate, una parola chiave per Bergman.
Estate è la stagione in cui fioriscono le illusioni, le promesse della giovinezza, della vita, ma è una stagione breve, come l'estate svedese che porta con sé, già mentre si svolge, i segnali dell'autunno imminente, dell'approssimarsi del declino e dell'incombere delle ombre della solitudine e della morte (autentiche ossessioni di Bergman).
Il cineasta all'epoca di questo film era preda di una grave depressione e pensava al suicidio. Ha spesso dichiarato che esitava tra il mettere fine ai suoi giorni o realizzare una commedia.
Nacque così un'opera comica sotto la quale si nascondeva il dramma personale del suo autore. Dietro la levità, il brio, lo spumeggiare dei dialoghi, dietro il marivaudage, Sorrisi di una notte d'estate, nasconde le angosce e i torpori del suo autore.
Tuttavia il film è percorso da una grande euforia e anche da un erotismo pronunciato per l'epoca, un invito permanente ai giochi d'amore in cui si sciolgono e si ricompongono le coppie.
E qui le coppie, colte sempre, come già abbiamo visto nei film precedenti, nei momenti di crisi sono tre e si ritrovano tutte riunite in una villa a imbastire i propri giochi amorosi.
E il racconto, come quasi sempre in Bergman, si coniuga al femminile, nel senso che le donne non sono viste da un punto di vista maschile, ma delineate con profonda complicità e tratteggiate con estrema sottigliezza. Laddove i personaggi maschili non sono che stereotipi.
Un racconto che si dipana senza esuberanze o stranezze di messa in scena, ma che si affida alla trasparenza della macchina da presa che disegna discretamente i suoi personaggi con i loro volti e le loro parole.
Un film, per concludere, che non è solo puro divertimento, ma come sempre in Bergman, un'occasione per riflettere sull'amore e sui rapporti umani.
IL CONFORMISTA di Bernardo Bertolucci (1970)
Dopo Strategia del ragno visto la settimana scorsa e prima di Ultimo tango a Parigi, c'è Il Conformista (1970) da Moravia, che si conferma, come abbiamo detto a proposito de Gli indifferenti, autore il più saccheggiato dal cinema degli anni 60' e '70.
Fin dall'infanzia Marcello Clerici (Jean-Louis Trintignant) è tormentato dall'assassinio che egli crede di aver commesso dell'autista che aveva tentato di abusare di lui.. Ossessionato dal rimorso, si sforza di rientrare nei ranghi. Sposa Giulia (Stefania Sandrelli), una giovane piccolo borghese. Diviene fascista per conformismo; viene inviato dai servizi segreti fascisti in Francia per avvicinare ed eliminare il suo vecchio professore di filosofia in esilio che lotta in un gruppo di resistenza antifascista, il professor Quadri. A Parigi Marcello, ufficialmente in viaggio di nozze, incontra il professore e la sua seducente moglie Anna (Dominique Sanda).
Anche nel Confomista come in Strategia del ragno si ritrovano temi e stilemi di Bertolucci.
Strategia del ragno e Il conformista hanno in comune il tema del tradimento, la presenza del passato che ritorna e il peso della figura paterna, con la differenza che ne Il conformista il figlio, Trintignant, tradisce il professor Quadri (la figura paterna), mentre in Strategia del ragno è Athos padre ad avere tradito. In ogni caso si tratta di due parricidi che suppongono un passato e una memoria.
Quanto alle marche stilistiche, Bertolucci anche qui adotta la sua strategia del ragno per avvolgere lo spettatore dentro una sottile rete di figure e citazioni, qui dominate dal cinema francese e dal cinema americano degli anni '30.
Molto nettamente il film si compone di due parti: la prima un puzzle fatto di flashback che prova a spiegare la personalità di Marcello, magnificamente interpretato da Jean-Louis Trintignant, a partire da un trauma infantile, la seconda, più lineare, culmina con il compimento della vicenda: la sequenza insostenibile di un assassinio, dilatato e ingigantito dal montaggio.
Ciò a cui mira il cineasta è rintracciare il mistero di un uomo che avrebbe potuto essere qualcosa di diverso da un fascista, se non l'avesse attanagliato il desiderio di essere normale. La mente corre subito alla banalità del male secondo Hannah Arendt, che teorizzò questa dismissione del pensiero, la sua abdicazione di fronte al totalitarismo. Marcello incarna questo sogno di essere come gli altri, lui che sembra solitario, che ha vissuto nell'infanzia episodi di sopraffazione e un rapporto omosessuale seguito da un presunto assassinio. La sua stessa famiglia, tra un padre pazzo e una madre dedita ai suoi cani e alla droga, rappresenta l'anormalità insopportabile. In fondo, a lui non resta che andare in una direzione opposta, vale a dire essere attore e non più vittima.
Se egli intravede una via d'uscita possibile allorché conosce a Parigi Anna, che l'opposizione dei colori caldi in Francia e desaturati in Italia grazie sempre alla fotografia di Vittorio Storaro mette bene in risalto, questa via si perde subito bastando la sua anima e i fascisti a rimetterlo in riga: il fatto è che, e lo si sa dai tempi di Camus, una volta messo il dito nell'ingranaggio non c'è più alcun' altra scelta se non andare fino in fondo. Marcello non può che perdersi.
Dentro questa analisi psicanalitica, Bertolucci abbozza ugualmente il quadro di un'Italia che non è ancora riuscita a digerire il suo fascismo: le scenografie sontuose, travolgenti, sono popolate di arrivisti mediocri; la religione, resa onnipresente dalle immagini, è un guscio vuoto; ciò che solo conta è il decoro, le apparenze.
Si è detto che Bertolucci filma come un esteta: la luce, le inquadrature, la scenografia, i fluidi movimenti di macchina sono di una padronanza assoluta, al limite della preziosità, ma l'impressione di gratuità che può scaturire da alcune scene (come quelle riprese da angolazioni oblique) si dissolve di fronte all'intelligenza della realizzazione. La messa scena in realtà prova a esprimere l'indicibile o ciò che è solo abbozzato nella sceneggiatura: la luce che inonda l'abbraccio nel treno, il gioco d'ombre quando il dialogo evoca la caverna di Platone, la separazione dei due sposi da una mensola alla fine del film, come quei piani aggiungono un significato secondo alla narrazione.
Fondandosi sulla bella e impetuosa musica di Geroges Delerue, Bertolucci compone una sorta di capolavoro distante, la cui freddezza spietata è il riflesso di una visione straordinariamente pessimista, quella di un mondo nel quale i puri sono impietosamente schiacciati. Una visione che ne fa uno dei film più cupi e strazianti sulla condizione umana.
LA COTTA di Ermanno Olmi (1967)
La cotta è un mediometraggio girato per la Rai nel 1967 che poi confluirà insieme ad altri due episodi, La Regina e Il Ragazzo di Gigliola, nel film distribuito in sala nel 1967 con il titolo Racconti di Giovani Amori.
E' il racconto delicato e profondo di amori adolescenziali; uno schizzo sociologico della nuova gioventù del benessere crescente e che si va via via tecnologizzando (lo stereo, la cinepresa); un piccolo romanzo di formazione e, come recitano i titoli "Una storia vera che potrebbe essere una fiaba" .
Ne è protagonista Alessandro, quindicenne vivace, spiritoso e profondamente romantico, a dispetto della sua teoria che vorrebbe l'amore organizzato industrialmente senza i tempi morti del corteggiamento (quasi un richiamo alla suggestione cinematografica hitchcockiana rilasciata a Truffaut nella famosa intervista. suggestione del cinema come vita reale senza i tempi morti, e il richiamo a Truffuat non è casuale, visto che dell'amore che fugge Truffaut se ne intendeva).
C'è una solida linea di continuità con Il posto con cui abbiamo aperto l'omaggio la settimana scorsa a Olmi, ma c'è continuità anche con i Fidanzati che vederemo subito dopo, sia sul piano narrativo, su quello dei motivi ricorrenti (ambientazione milanese, il ballo, l'ultimo dell'anno, l'umorismo lieve), che su quello della messa in scena (attori non professionisti, sceneggiatura minimalista). E c'è un tratto inconfondibile del cinema di Olmi, legato alla semplicità apparente della messa in scena, che si avvale invece di accorti strumenti espressivi, dal flashfoward con il quale il protagonista si vede proiettato nel futuro, ai primissimi piani che da soli bastano a raccontare una vita, strumenti che danno freschezza e spontaneità al racconto e al tempo stesso ne scandagliano la profondità.
CRONACA FAMILIARE di Valerio Zurlini (1962)
Evocare il nome di Valerio Zurlini implica quasi un lavoro di scoperta, tanto il cineasta appare come una figura dimenticata. L'autore di La ragazza con la valigia, di Estate violenta, film che abbiamo proiettato in precedenti rassegne, risulta danneggiato da un'opera concepita con lentezza e complessivamente non molto fitta (otto film in ventidue anni), e da una discrezione che l'ha sempre tenuto lontano dalla mondanità legata al mondo dello spettacolo, e messo in ombra dai grandi cineasti degli anni '60 e 70, Fellini, Antonioni, Pasolini ecc. Eppure è stato uno dei più grandi autori del cinema italiano. Autore di un cinema 'silenzioso', attento alla psicologia dei personaggi e rispettoso nei confronti della Storia, Zurlini è uno dei registi più importanti e al tempo stesso meno noti della sua generazione.
Valerio Zurlini (1926-1982) coltivava un'idea alta di cinema, fatta di misura, nitore, finezza, equilibrio. I suoi punti di riferimento sono da ricercare più nelle arti figurative, nella letteratura, nella Storia, che nella realtà o nella cronaca; e in tutti i suoi film si avverte una forte tensione lirica. Si può immaginare quanto questo suo rigore e le sue ambizioni artistiche fossero condivise da chi gli doveva finanziare i film: così la fama di persona difficile, spinosa, incapace di compromessi, contribuì a renderlo un regista isolato.
Tuttavia non si può pensare ai suoi film come a freddi esercizi intellettualistici. Al contrario essi sono dotati di una grande forza spettacolare ed emotiva. I sentimenti, i moti dell'animo, i trasalimenti interiori sono al centro dei suoi film e per questo è stato definito “reporter dell'anima”, ma al tempo stesso anche un vigoroso incisore di sfondi storici.
Si pensi ad esempio a Estate violenta che abbiamo proiettato due anni fa, dove una storia privata è ingrandita e diventa straordinaria, cioè necessaria, se si presenta sullo sfondo un grande avvenimento storico.
Si pensi ancora al film di stasera, Cronaca familiare.
Come Le ragazze di San Frediano, lungometraggio d'esordio di Zurlini del 1954, anche Cronaca familiare si ispira a un romanzo di Vasco Pratolini (autore più volte portato sugli schermi, Cronache di poveri amanti di Lizzani, Metello di Bolognini, Lo scialo mini serie tv di Franco Rossi; e a sua volta sceneggiatore di molti film importanti a cominciare da Paisà). E questo romanzo è forse il libro più intimo di Pratolini. Cronaca familiare (1962) è una pacata e intensa contemplazione del dolore.
E' la rievocazione fatta dal protagonista, Marcello Mastroianni, del rapporto con il fratello minore, Jacques Perrin, attore già protagonista ne La ragazza con la valigia e che lo diventerà poi nell'ultimo film di Zurlini e cioè Il deserto dei tartari. Sullo sfondo la Storia, dall'ascesa del fascismo alla seconda guerra mondiale, che come già detto non fa che ingrandire, secondo le parole stesse di Zurlini, e conferire straordinarietà a una vicenda privata.
Una vicenda privata dolorosa, che però non scade mai nel patetismo, nel sentimentalismo, un'opera di grande pudore, grazie a una messa in scena fatta di ellissi, di non detto; in cui perciò le prove attoriali sono assai misurate, e in particolare quella di Marcello Mastroianni, che perciò stesso diventa straordinaria; in cui la ricerca espressiva si evidenzia nella fotografia di Giuseppe Rotunno che ricrea i toni cromatici di Ottone Rosai e di Giorgio Morandi. diventando equivalenti della tempesta dei sentimenti che si dipanano. E' come se Zurlini dipingesse gli stati d'animo.
Il film ottenne il Leone d'oro alla Mostra di Venezia.
DE OLIVEIRA
Cineasta davvero singolare Manoel de Oliveira nella storia del cinema della cui vita lui ha percorso una gran parte. E' uno dei pochi cineasti, infatti, la cui carriera ha avuto inizio nei tempi del muto e il cui primo lungometraggio, Aniki Bobo, uno dei due film in programma stasera, sia degli anni quaranta.
Ecco, la miracolosa longevità di de Oliveira (nato nel 1908 è morto nel 2015, all'età dunque di 107 anni) è proprio uno degli elementi che lo rendono così singolare. L'altro elemento che ne ha caratterizzato la carriera è stata la frammentarietà. A 20 anni realizza il documentario Douro, Faina Fluvial, una sorta di sinfonia urbana (sotto la chiara influenza di Berlino, sinfonia di una grande città del 1927 di Walter Ruttman) poi una serie di altri cortometraggi e documentari e sceneggiature, ma il suo esordio nel lungometragio di finzione avviene solo nel 1942 con il già citato Aniki Bobo e per il secondo bisognerà aspettare il 1963, a 54 anni (nel frattempo si era occupato dell'impresa di famiglia, aveva coltivato le sue passioni sportive, il salto con l'asta e le corse automobilistiche). E così ancora per molti anni (un film, pausa per lunghi anni, un altro film) finché dal 1985, quasi ormai già ottantenne e fino all'ultimo, realizzerà quasi un film all'anno per un totale di circa 25 film senza contare i cortometraggi e i documentari che pur continuava a girare: la gran parte dunque della sua ampia opera. Un'opera che ha sperimentato numerose possibilità estetiche senza rimanere rinchiuso in un unico stile immutabile. E in cui si ritrovano almeno due costanti: l'indifferenza, finanche il rifiuto, verso la verosimiglianza e una coscienza forte del valore artistico del cinema.
Sono tanti i luoghi comuni e i pregiudizi che circolano a proposito di de Oliveira, per quanto poco si conosca la sua opera.
Si dice che sia un autore difficile, apprezzato solo da cinefili da cineteche e festival. Eppure molti suoi film (Francissca, I Cannibali, La valle del peccato) sono stati i maggiori incassi in Portogallo.
Si dice che sia un cineasta che fa film lunghissimi. Ce ne sono alcuni che durano anche sette ore e mezzo, è vero, ma nessun regista ha girato tanti cortometraggi e documentari brevi come lui. E inoltre i film che proponiamo stasera ne sono un chiara smentita, durano uno, Porto della mia infanzi, 60', l'altro, Aniki Bobo poco più di un'ora.
Si dice che sia un cineasta letterario e teatrale, verboso addirittura, dai lunghi dialoghi e monologhi.
Si dice che sia un autore “lento” con inquadrature che durano
Nella lunga carriera di de Oliveira è possibile rinvenire diversi periodi in cui prevalgono questa o quella ispirazione: ora la vena epico storica e di critica sociale, propria dell'ultimo periodo, ora la vena fantastica (talvolta l'una e l'altra convivono nello stesso film); il gusto per gli adattamenti letterari nonostante la voglia di mantenersi infedele. Ma sempre centrali sono i temi a lui più cari come la paura, la colpa, il sesso. La nostalgia per l'armonia perduta e più specificamente il tema dell'androginia, intesa come aspirazione all'unità sessuale; l'ambivalenza tra santità e perversione; la riflessione sul potere della finzione in qualunque forma essa si manifesti: cinema, letteratura, teatro, opera, musica.
Di profonda originalità, l'opera di de Oliveira associa ad ampie meditazioni sulla storia una saporita ironia. Grande cineasta della parola, egli ha manifestato anche un grande temperamento visuale che ne ha fatto uno dei grandi creatori di immagine del cinema contemporaneo.
E veniamo ai film di stasera.
DE OLIVEIRA: ANIKI BOBO (1942)
Aniki Bóbó è la formula magica che unisce una piccola banda di ragazzini che si ritrovano a giocare per le strade di Porto. Dopo la scuola, i bambini vanno a giocare sulle rive del fiume Douro. Carlitos, timido e romantico, è innamorato della bella Teresinha, alla quale fa la corte anche il 'duro' Eduardito. Teresinha incoraggia entrambi.
Primo lungometraggio di Manoel de Oliveira, Aniki-Bóbó venne realizzato undici anni dopo Douro, faina fluvial (1931), il cortometraggio che aveva suscitato le prime attenzioni nei confronti del regista. Nel 1942 i responsabili della politica cinematografica portoghese lo scelsero per farlo partecipare al Festival di Venezia; ma, non ancora terminato, non venne preso in considerazione. Oggi possiamo chiederci quale sarebbe stata l'accoglienza che il film avrebbe ricevuto in Italia, in un'epoca in cui la critica esaltava il realismo e il cinema di testimonianza. Antonioni presentava i suoi cortometraggi sul Po, c'erano i film di Fernando Cerchio e di Mario Damicelli, Visconti stava preparando Ossessione. Aniki-Bóbó avrebbe potuto essere una sorta di precursore del neorealismo. Ma la critica europea lo conobbe soltanto nel 1961, quando il film venne presentato a Cannes. D'altra parte la sua vicinanza al neorealismo italiano è discutibile. Certo vi sono somiglianze: l'uso di attori non professionisti (tranne il commerciante e il professore), la scelta di girare in ambienti reali, l'invito alla pace espresso nel finale del film. Ma se tutto questo costituiva una novità assoluta per il cinema portoghese (all'epoca nella sua fase di 'telefoni bianchi'), l'ispirazione di Oliveira non proviene né dai maestri russi, né dalla letteratura impegnata americana e nemmeno dal realismo poetico francese.
All'origine di Aniki-Bóbó c'è il racconto di uno scrittore, Rodrigues de Freitas, collaboratore assai stimato della rivista che in Portogallo conduceva con maggior vigore la battaglia per l'indipendenza dell'arte contro il cosiddetto 'impegno' artistico. Anche se de Oliveira ritrae con sincerità e molto amore la vita dei bambini poveri di Porto, non ha intenzione di realizzare un documento di denuncia. Ciò che gli interessa è rintracciare in chi sta vivendo la fine dell'infanzia quei sentimenti che, molto più tardi, domineranno le sue opere della maturità: il desiderio e il senso di colpevolezza, la paura e la gelosia, il rimorso e la punizione. Come lo stesso regista ha dichiarato, "cercando di raccontare una storia semplice, volevo che i bambini rispecchiassero i problemi degli adulti, in loro ancora allo stato embrionale: la contrapposizione tra i concetti di bene e di male, di odio e di amore, di amicizia e di ingratitudine". In questo senso, quindi, la storia d'amore di Aniki-Bóbó è il compendio di una storia d'amore tra adulti. E l'inizio del film (il bambino che rompe il suo giocattolo e viene incitato a "seguire sempre la retta via") diventa allora l'introduzione a un mondo dominato dalla paura, in cui è sempre presente il castigo. Possiamo pensare a Hitchcock, e il riferimento non è gratuito: Oliveira cita Rebecca (Rebecca ? La prima moglie, 1940) come il film che più l'aveva influenzato all'epoca di Aniki-Bóbó. Il negozio si chiama Bottega delle Tentazioni e quello della bambola è uno sguardo che spaventa. Nel sogno di Carlitos, dopo l'incidente, non è un caso che l'uomo con la bambola (il negoziante) assuma le sembianze del demonio, terrorizzando il piccolo con la minaccia delle fiamme dell'inferno. La colpa che provoca i rimorsi di Carlitos non è soltanto il furto; si sente colpevole anche perché desidera Teresinha. Da questo punto di vista, la sequenza in cui Carlitos regala la bambola a Teresinha è prodigiosa. Il bambino la sorprende di notte, arrivando dall'alto (come un angelo o un diavolo) e la chiama mentre lei è già a letto (grazie a un cambiamento nell'illuminazione e nelle inquadrature, Teresinha appare in queste immagini più grande, come un'adolescente). Lei si alza, indossando una camicia da notte bianca, e accetta il regalo e la dichiarazione di Carlitos. Ma il momento culminante ? quello del bacio ? viene interrotto dalla caduta del ragazzo, con un'evidente connotazione sessuale. Colpevole di un furto, colpevole di uno 'stupro', Carlitos sarà poi accusato di essere un assassino. Quando la sua innocenza viene riconosciuta, restituisce la bambola (cioè si libera del furto) e 'sposa' Teresinha, liberandosi anche dello 'stupro'. L'immagine finale è quella di una coppia che porta a spasso il proprio figlio.
DE OLIVEIRA: PORTO DELLA MIA INFANZIA (2001)
De Oliveira con la sua voce off ci fa da guida e ci invita a scoprire il suo passato come come se stessimo visitando una città straniera. Questa città è Oporto, dove è nato nel 1908, dove ha realizzato il suo primo film Douro, faina fluvial (1931), dove ambienterà il suo primo lungometraggo Aniki Bobo del 1942. Ci porta lì dove gran parte della scenografia ha oggi cambiato fisionomia. Il tal cinema, la tale pasticceria, quel caffé sono spariti. E lui fil ciò che li ha sosituiti o ricostruisce l'atmosfera dei luoghi dell'epoca orchestrandovi scenette luminose e profumate.
La magia di questo film risiede nel far calare su di noi un dubbio, sia pure lieve, su tutto ciò che ci mostra, comprese le immagini d'archivio, al punto che ci si chiede: ma quel dandy è davvero il grande Pessoa in persona?
Non c'è memoria senza artificio, sembra suggerire de Oliveira, in questo film bello e ingannevole come una leggenda, in cui trova posto la prima emozione romantica. Quella del cinema, di tutto il cinema: dal muto al sonoro.
Film dunque sulla memoria, sugli artifici, la seduzione e gli inganni della memoria. Sul cinema, sugli artifici e gli inganni del cinema.
FELLINI
Il nostro omaggio a Fellini nel venticinquennale della sua morte si articola in tre serate, nel corso delle quali, accanto a capolavori come La strada, Le notti di Cabiria e Amarcord, presenteremo dei film piuttosto rari su di lui, a cominciare dal film che vedremo adesso e cioè “Fellini” di André Delvaux.
Un film inedito realizzato dal cineasta belga André Delvaux, Fellini è una lunghissima intervista effettuata per la televisione belga dopo il successo della Dolce vita e condotta da Dominique Delouche, assistente di Fellini dal '54 al '60 e amico del maestro.
Il film registra la vita del cineasta in quattro tempi: 1) L'infanzia e gli inizi; 2) I primi film; 3)i film con Giulietta Masina; 4)La dolce vita e il neorealismo. Noi ne vedremo stasera le prime due e martedì prossimo le altre due.
Una confessione felliniana? Agli inizi degli anni '90 il maestro non esiterà a dichiarare: “Sono un gran bugiardo”.
Prendiamo l'episodio “leggendario” della sua fuga dal collegio dei preti dove si trovava, a Fano, fuga che lo condusse direttamente in un circo dove si sentiva di casa. E' un'invenzione, gli chiede Dominique Delouche, incantato dal racconto, ma dubbioso. Ma che importa, gli risponde Fellini, se sia l'esatta verità: ciò che conta sono le quattro o cinque immagini che gli sono rimaste e di cui si nutriranno i suoi film futuri, e noi con loro.
Ascolteremo dunque con un piacere infantile Fellini parlare del ragazzo che era, vero e proprio istrione che simula la morte per attirare l'attenzione; o ancora sentirgli raccontare di come truffava gli americani quando lavorava come caricaturista al giornale umoristico Marc'Aurelio.
Il cineasta si sofferma poi su Rossellini e sul ruolo fondamentale giocato da Paisà nella sua vita; Antonioni che evoca Fellini e la sua maniera di forzare la realtà e ancora Peppino De Filippo, Alberto Sordi, Leopoldo Trieste, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Nino Rota; Fellini parla di loro o essi stessi parlano del maestro.
Poi c'è Giulietta Masina che è al centro della discussione, “la fatina” del cineasta secondo le sue proprie parole. La terza parte si propone dunque quasi come un duetto in differita, nella quale Fellini e Giulietta parlano di volta in volta l'uno dopo l'altra, e parlano con delicatezza dei loro rapporti cinematografici. Interviene anche Pasolini per ricordare il suo lavoro come sceneggiatore per Le notti di Cabiria.
Il film temina sullo scandalo de La dolce vita, vero caso nazionale, quasi uno scontro di classe che oppose i favorevoli e i contrari. Fellini fu rosolato sullo spiedo, ma ottenne comunque la Palma d'oro.
Era un edificio che stava per crollare, una certa Italia che Fellini voleva filmare. Tutta l'estetica del neorealismo che veniva rimessa in discussione, apparentemente, come sostiene Zavattini: “ Mentre con La strada se ne allontana, con La Dolce vita Fellini resta legato a una certa coscienza sociale e storica neorealista. Ma il neorealismo cos'era? Certamente filmare con una certa umiltà, ma l'umiltà, sostiene Fellini, non significa assenza di fantasia, di immaginazione.
FELLINI: AMARCORD (1973)
"Il film vuol essere il ritratto della provincia italiana, non solo di quella di una volta, ma anche quella d'oggi; ed è per questo che l'elemento che più intimamente caratterizza l'episodio del federale cioè il condizionamento buffonesco, di teatralità, di infantilismo, la soggezione a un potere burattinesco, a un mito ridicolo, è proprio il centro del film, il suo fulcro. Il fascismo è stato un modo di guardare la vita da un punto di vista non personale, ma collettivo" (Federico Fellini).
“Non si può certo dire che il regista sia stato tenero verso la società boccheggiante sotto il tallone della dittatura: come 'Bildungsroman', o romanzo dell'educazione sentimentale di Titta, Amarcord delinea il deprimente perimetro dell'Italietta con rancore non sopito e rigore assoluto. Il tono umoristico del ricordo non attenua l'implacabilità della denuncia; e gli anni del consenso, ancora una volta controcorrente rispetto alla cultura ufficiale che lo sta riscoprendo, ne escono ridimensionati in tutta la loro povertà morale e culturale. È curioso che il più severo giudizio politico su un'epoca sbagliata venga dall'ispirazione di un artista dichiaratamente impolitico.”
(Tullio Kezich)
Parole ancor oggi, anzi, soprattutto oggi, di gran peso.
"La provincia di Amarcord è quella dove tutti siamo riconoscibili, autore in testa, nell'ignoranza che ci confondeva. Una grande ignoranza e una grande confusione. Con questo non voglio minimizzare le cause economiche e sociali del fascismo. Voglio dire che quello che mi interessa è la maniera, psicologica, emotiva, di essere fascisti: una sorta di blocco, di arresto alla fase dell'adolescenza.
Tale arresto, tale repressione del naturale sviluppo di un individuo, credo che per forza debba scatenare dei grovigli compensatori. È forse per questo che quando la crescita si risolve in un'evoluzione tradita e delusa, il fascismo, per taluni aspetti, può perfino sembrare un'alternativa alla delusione, una specie di velleitaria e sgangherata riscossa.
Fascismo e adolescenza continuano ad essere in una certa misura stagioni storiche permanenti della nostra vita. L'adolescenza, della nostra vita individuale; il fascismo, di quella nazionale: questo restare, insomma, eternamente bambini, scaricare le responsabilità sugli altri, vivere con la confortante sensazione che c'è qualcuno che pensa per te, e, una volta è la mamma, una volta il papà, un'altra volta è il sindaco, o il duce, e poi il vescovo, e la Madonna e la televisione."
(Federico Fellini)
Le eterne premesse del fascismo mi pare di ravvisarle appunto nell'essere provinciali, nella mancanza di conoscenza dei problemi concretamente reali, nel rifiuto di approfondire, per pigrizia, per pregiudizio, per comodità, per presunzione, il proprio rapporto individuale con la vita. Vantarsi di essere ignoranti, cercare di affermare se stessi o il proprio gruppo non con la forza che viene dall'effettiva capacità, dall'esperienza, dal confronto della cultura, ma con la millanteria, le affermazioni fini a se stesse, lo spiegamento di qualità mimate invece che vere. Anche l'esibizione del sesso è fascismo. Il sesso dovrebbe essere un'emozione; e invece rischia di diventare una parata, una cosa buffonesca e inutile, una brutta cosa che le donne subiscono passive e attonite. Non si può combattere il fascismo senza identificarlo con la nostra parte stupida, meschina, velleitaria; una parte che non ha partito politico, della quale dovremmo vergognarci, e che a respingerla non basta dire: io milito in un partito antifascista. Perché quella parte sta dentro ciascuno di noi, e ad essa già una volta il 'fascismo' ha dato voce, autorità, credito.
(Federico Fellini)
FELLINI: LE NOTTI DI CABIRIA (1956)
Giulietta Masina, già vista ne La Strada, interpreta qui con grande sensibilità il ruolo di una prostituta che cerca di uscire dalla sua condizione. Fellini dipinge con crudezza le turpitudini di cui l'uomo si rende capace, ma anche con un certo grado di comprensione della natura umana.
Giulietta Masina ha ottenuto il premio al festival di Cannes per questa interpretazione così autentica.
Fellini si affida a uno dei suoi soggetti preferiti: la rappresentazione di un pellegrinaggio alla Vergine, diventa una vera galleria degli orrori.
La strada, Il Bidone e Le notti di Cabiria formano una trilogia cristiana nel mondo degli umili e degli emarginati ancora fortemente contrassegnata dal neorealismo, ma che contiene già accenti barocchi, influenze del varietà e del circo, che Fellini esacerberà nei film successivi.
Le notti di Cabiria è l'ultimo titolo prima della rottura estetica e tematica che La dolce vita, due anni più tardi, introdurrà nella carriera del maestro. Il capolavoro che si emancipa dalle molle drammatiche troppo oleografiche e inventa una forma inedita di racconto senza struttura apparente, dove si mescolano onirismo, documentario, satira e favola morale.
FELLINI: LA STRADA (1954)
La Strada, 1954, quarto film di Fellini dopo Luci del varietà, Lo sceicco bianco e I Vitelloni è l'opera che lo consacrò a livello mondiale, vista la duplice vittoria ai Nastri d'Argento, il Leone d'oro e la vittoria agli Oscar come miglior film straniero tre anni dopo, per di più nel primo anno in cui venne istituita questa categoria.
Racconta una storia d'amore e di gelosia nel mondo circense al quale Fellini, come si sa, era particolarmente legato e al quale ritornerà spesso nel corso della sua carriera. Zampanò (un Anthony Quinn in una delle sue migliori prove) si esibisce nel numero, molto metaforico, in cui deve liberarsi dalle catene, quelle che gli serrano il cuore. Ha bisogno di un'assistente. Compra dalle mani della madre Gelsomina (Giulietta Masino), una ragazza che interpreta il ruolo di un clown dalle movenze chapliniane, silfide fragile che incapace di imporre la sua personalità al mondo sopravvive grazie al mimetismo: imitando le movenze delle scimmie per esempio o muovendo le braccia come rami di un albero. Quando raggiungono un circo ambulante, Gelsomina rimane affascinata da un acrobata, il Matto (Richard Basehart) e Zampano, che ancora non ha saputo confessare a sé stesso i propri sentimenti, che non ha ancora liberato il suo petto dalle catene che gli serrano il cuore e perciò maltratta Gelsomina, viene colto da gelosia.
La strada si presenta come una favola, raccontata con uno stile che tende a prendere le distanze dal neorealismo di cui pure Fellini è stato un componente importante, come sceneggiatore di molti film e collaboratore di Rossellini (Roma città aperta, Paisà, Francesco giullare di Dio, Europa '51) e a cui è particolarmente legato.
Evidentemente Zampano e Gelsomina sono degli archetipi, delle figure semplici, mosse da emozioni e desideri i più elementari. Gli avvenimenti sembrano predestinati e i personaggi costretti ad agire come se lo fossero, ciò che in definitiva contraddistingue la tragedia. Eppure sono personaggi straordinariamente vivi e pulsanti che sono rimasti nell'immaginario cinematografico di ciascuno di noi.
Di questo film mitico, Bazin disse: “E' la storia di un uomo che impara a piangere...”
I FIDANZATI di Ermanno Olmi (1963)
Come nel Posto anche nei Fidanzati Olmi ha il suo tocco inconfondibile, una grazia eccezionale nel far parlare le piccole cose e i piccoli uomini, nello svelare gli ambienti e nel cogliere le fisionomie.
Terzo lungometraggio di Olmi, I fidanzati (1963) è emblematico di un'arte spoglia, fondata su una sceneggiatura minimalista: Giovanni, operaio milanese, viene trasferito dalla società per cui lavora in Sicilia dove dovrà stare per due anni mentre la fidanzata Liliana rimane a Milano.
Un aneddoto semplicissimo svolto con l'abituale pudore del cinema di Olmi, e tuttavia narrato con un'inedita ricerca di linguaggio, nel tentativo di stabilire una nuova dimensione del tempo cinematografico. La realtà e i ricordi, l'esperienza e i sogni si confondono nella cronaca dell'esistenza di Giovanni. I motivi di Olmi ci sono tutti: la timidezza nell'approccio amoroso, il ballo, l'umorismo sempliciotto. L'osservazione della realtà a un livello elementare.. Il mondo di Giovanni è visto dalla macchina da presa attraverso gli occhi del personaggio: il narratore riesce a mimetizzarsi completamente, non aggiunge nulla, non infiora il discorso di considerazioni estrinseche. E' questo che dà al film il valore di una testimonianza diretta, di un documento umano.
Olmi è uno dei pochi autori che sa raccontare dall'interno la psicologia di un operaio, con la ricchezza sentimentale che sta dietro l'apparente corrività, con il quotidiano visto attraverso il microscopio della poesia. E Il tema di Olmi è sempre lo stesso: la solitudine dell'uomo nel mondo del lavoro, la sua esigenza di solidarietà e di amore.
La prima sequenza, quella del ballo in una balera che ritornerà come un leitmotiv, stabilisce il tono e l'impianto estetico del film (poca o nessuna musica extradiegetica, dialoghi parsimoniosi, recitazione contenuta degli attori non professionisti). Ma già questa sequenza è tagliata da flashback che interromperanno la narrazione puntualmente, come se fosse una memoria involontaria e il film oscillerà tra presente e ricordi, fino alle magnifiche scene finali di lettura delle lettere che i due fidanzati si inviano. In quel punto Olmi perviene a un'alchimia miracolosa che trasforma questo film in apparenza freddo in una fiammeggiante storia d'amore.
Ma durante il film Olmi segue il percorso di Giovanni, esiliato apatico e muto; privo di avvenimenti, questa prima parte si incentra su dettagli minimi, anodini, che compongono un paesaggio mentale di noia; il caldo soffocante si accorda con una sensazione di soffocamento, che la fabbrica rende fisico con un intreccio di linee verticali e orizzontali. Simbolicamente, il cambiamento di tempo va di pari passo con l'espressione dei sentimenti che si andranno liberando.
Per Olmi non si tratta di raccontare una storia con un inizio e una fine, ma di prelevare dei momenti, di offrire allo sguardo il mondo, così così un cane in una chiesa diventa evento da notare oppure le confidenze di un cameriere. Non sono le peripezie che fanno il film, ma gli sguardi su questi piccoli niente; se il cineasta non è certo un formalista, egli sa suscitare dall'inquadratura un'emozione estetica che d'improvviso straripa in un'emozione tout court.
Elio Petri appunti su un autore, a cura di Paola Petri, La Biennale Venezia, 2007
Ingmar Bergman, Sergio Trasatti, Il Castoro, 2011
Bernardo Bertolucci, Stefano Socci, Il Castoro, 2008
Storia del cinema mondiale, a cura di Gian Piero Brunetta, Einaudi, 2000
I volti e le mani - Il cinema di Ermanno Olmi, a cura di Benedetta Tobagi, Feltrinelli, 2008
Tutti i film di Federico Fellini, Enrico Giacovelli, Lindau, 2002
Il film sessanta- Il cinema degli anni 1962-1966, Tullio Kezich, Il Formichiere, 1979
Ermanno Olmi - Il mestiere delle immagini, diario in pubblico di un'amicizia, Tullio Kezich, Falsopiano, 2004
News pubblicata martedì 21 maggio 2019