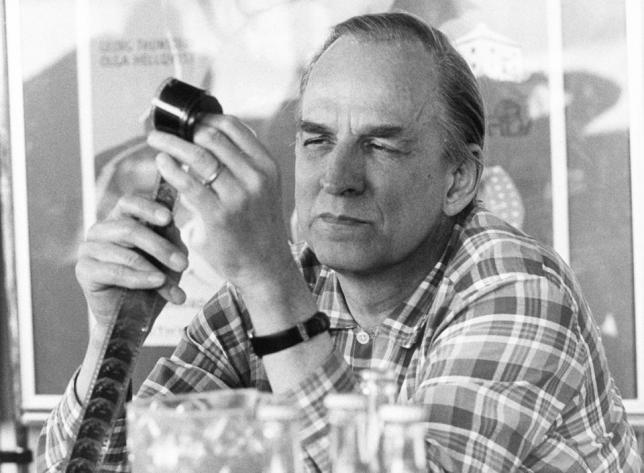A conclusione della rassegna Trame e intrecci (mediatecanapoli.it/articoli/…">mediatecanapoli.it/articoli/…">mediatecanapoli.it/articoli/…...), riportiamo le schede critiche elaborate per la presentazione di alcuni dei film proiettati e contenenti il profilo di alcuni maestri del cinema a cui abbiamo reso omaggio (Bergman, Fellini, De Oliveira):
Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica (1970)
Gli indifferenti di Francesco Maselli (1964)
L'isola di Arturo di Damiano Damiani (1962)
Myazaki: Never Hending Man. Hayao Myazaki di Kaku Arakawa (2016), Si alza il vento di Hayao Myazaki (2013)
Padre padrone di Paolo e Vittorio Taviani (1977)
La ragazza di Bube di Luigi Comencini (1964)
San Michele aveva un gallo (1973) di Paolo e Vittorio Taviani
Storia immortale di Orson Welles (1968)
Lo straniero di Luchino Visconti (1967)
Strategia del ragno (1970)
La viaccia di Mauro Bolognini (1961)
Gli indifferenti di Francesco Maselli (1964)
L'isola di Arturo di Damiano Damiani (1962)
Myazaki: Never Hending Man. Hayao Myazaki di Kaku Arakawa (2016), Si alza il vento di Hayao Myazaki (2013)
Padre padrone di Paolo e Vittorio Taviani (1977)
La ragazza di Bube di Luigi Comencini (1964)
San Michele aveva un gallo (1973) di Paolo e Vittorio Taviani
Storia immortale di Orson Welles (1968)
Lo straniero di Luchino Visconti (1967)
Strategia del ragno (1970)
La viaccia di Mauro Bolognini (1961)
GIARDINO DEI FINZI CONTINI di Vittorio De Sica (1970)
L'incontro di De Sica con Bassani, che non è stato un incontro propriamente felice, se non sul piano della resa artistica del film, dato che Giorgio Bassani che pure aveva partecipato alla stesura della sceneggiatura, ritirò la firma dai titoli di coda perché riteneva che il film non avesse rispecchiato fedelmente il suo romanzo (De Sica e Ugo Pirro avevano modificato il racconto dell' infanzia ripercorsa in flashback laddove essa si dispiega linearmente all'inizio del romanzo e soprattutto il finale commovente), quell' incontro è al centro della nostra serata.E questo fatto ci riporta fatalmente alla questione annosa e impossibile da risolvere del confronto tra cinema e letteratura, della fedeltà del film al testo. Il film e il romanzo, sembra banale dirlo, sono due forme espressive profondamente diverse e come tali incomparabili. Un film tratto da un libro è sempre liberamente ispirato e nulla più. E i cosiddetti tradimenti, anche se significativi, altro non sono che la legittima impronta personale di un autore cinematografico. Mutata la forma espressiva non può che esserne diversa anche la sostanza. Il film dunque va giudicato in sé e non se sia stato più o meno fedele al testo di partenza. Tutte le migliori opere cinematografiche tradiscono sempre, come ebbe a dire Moravia, autore tra i maggiori ispiratori del cinema, e non solo di quello italiano.
La filmografia di Vittorio De Sica ha punteggiato, come raramente accade in un cineasta italiano, nel corso di quarant'anni i sussulti di un paese, i momenti cruciali della sua storia. All'indomani della seconda guerra mondiale egli è uno dei più sorprendenti cantori della miseria diffusa di un paese in rovina (Ladri di biciclette, Sciuscià, Umberto D, Miracolo a Milano, capolavori del neorealismo); negli anni '50 da attore è protagonista di numerosissime commedie popolari (come la serie di Pane, amore) destinate a rendere più sopportabile il difficile destino degli italiani; durante gli anni '60 in pieno boom economico egli conferisce alla produzione comica eleganza e raffinatezza (Il boom, Ieri, oggi e domani, Matrimonio all'italiana, alcuni suoi titoli di quegli anni). Poi, dopo un periodo in cui la sua vena sembrava essersi esaurita, il gran ritorno, con il film di stasera. Erano gli anni '70 all'inizio dei quali l'Italia è agitata dai sussulti politici degli anni di piombo e in cui i giovani sembrano subire un vero e proprio richiamo verso il fascismo, simbolo di un'Italia conquistatrice.
Adattando il romanzo di Giorgio Bassani, De Sica è come se s'incaricasse dunque di ricordare loro il vero dramma che rappresentò l'ascesa del fascismo e i mali che causò al paese. Il racconto ritrae il destino dei giovani di allora mentre le leggi fasciste antisemite diventano sempre più opprimenti. Il giardino dei Finzi Contini, ricchi ebrei aristocratici di Ferrara, funge da rifugio illusorio di fronte alla cupezza che si va diffondendo, dove Micol e Alberto i due giovani fratelli della famiglia vi si isolano lontano da tutte le interdizioni imposte agli ebrei, insieme con una loro piccola cerchia di amici. Tra essi Giorgio (Lino Capolicchio), segretamente innamorato di Micol (Dominique Sanda) dai tempi dell'infanzia, che sembra provare lo stesso sentimento, ma gli si rifiuta. Un rifiuto diversamente interpretabile, come effetto sottile della differenza di classe tra i due o soprattutto come paura di un futuro oscuro che obbliga a vietarsi la felicità del presente.
Il film è intriso di poesia a cui contribuisce non poco l'introduzione del dispositivo narrativo del flashback, che ci riporta all'amore d'infanzia tra Micol e Giorgio (un giovanissimo Alessandro D'Alatri), e comunque grazie alla fotografia di Ennio Guarnieri che dà un'atmosfera di sogno vaporoso, come un ultimo momento di pace prima dell' orrore che si annuncia (i segni si vanno accumulando poco a poco).
Pur preoccupato di allestire uno spettacolo popolare, De Sica ha trovato , come all'epoca disse Tullio Kezich, toni sommessi e coloriture sfumate che raramente si incontrano nei film spettacolari.
Con questo film, uno dei pochi senza Zavattini, e uno dei più toccanti, De Sica vinse l'Orso d'oro a Berlino e l'Oscar al miglior film straniero, il quarto per lui dopo Ladri di biciclette, Sciuscià e Ieri, oggi e domani.
GLI INDIFFERENTI di Francesco Maselli (1964)
Gli incontri di Alberto Moravia con il cinema sono stati assidui, sia per quanto riguarda la trasposizione cinematografica dei suoi romanzi e racconti, sia per quanto riguarda il ruolo di Moravia stesso nel cinema quale sceneggiatore e critico cinematografico (da fine anni ' 50 e per tutti gli anni '70 sarà il critico dell'Espresso). E' stato forse l'autore più saccheggiato da produttori e cineasti, soprattutto negli anni '50 e '60, probabilmente per la spregiudicatezza, per l'epoca, dei temi ma anche per le attitudini visive della scrittura moraviana.
Sarebbe lunghissimo l'elenco di tutti i film tratti dai suoi romanzi e racconti, ne cito solo quelli più riusciti a giudizio dello stesso Moravia: La provinciale di Mario Soldati (1953), La ciociara di De Sica (1960), Il disprezzo di Godard (1963), Il conformista (1970) di Bertolucci che vedremo tra alcune settimane e Moravia vi annoverava anche Gli indifferenti di Citto Maselli, film del 1964, il film di stasera.
Tutti film dalla forte impronta personale e originalità, che Moravia stesso apprezzava molto proprio a causa della loro infedeltà ai suoi testi, e che dirà: “Un autore non può chiedere al regista di essere fedele, soprattutto se il regista è un artista originale... gli può chiedere soltanto di fare un buon film. Nell'infedeltà riconosco l'originalità dell'artista”. Come si vede una posizione completamente diversa da quella della Morante che invece lamentava proprio l'infedeltà a proposito dell'isola di Arturo.
Il romanzo è del 1929, romanzo d'esordio di Moravia, forse il suo capolavoro. Il film del 1964, quarto film di Francesco Maselli detto Citto.
Maselli, oggi novantenne, è stato un enfant prodige del cinema italiano, enfant prodige tout court. A 13 anni partigiano, a 14 si iscrive al PCI, a 17 al Centro sperimentale di cinematografia; appena diplomato a 20 anni diventa aiuto regista e sceneggiatore di Antonioni per Cronaca di un amore e La signora senza camelie e per Visconti; a 23 l'esordio dietro la mdp con l'episodio Storia di Caterina de L'amore in città.
Pur formatosi nel periodo del neorealismo, la ricerca espressiva di Maselli è sempre stata molto personale e ha visto fondersi l'impegno politico e sociale con la riflessione sull'ambiguità e i vizi della borghesia e lo scavo psicologico, che in una seconda fase della sua carriera si è principalmente concentrato sulla figura femminile.
L'incontro dei due, Maselli e Moravia, doveva avvenire. Maselli è un regista sensibile a una poetica di crisi e all'analisi del milieu borghese; Moravia, un romanziere che della borghesia, dei suoi malesseri e del suo disfacimento è stato un critico acuto e corrosivo.
Anni '20 a Roma. I destini degli Ardengo, di Mariagrazia e dei suoi due figli, Carla e Michele, famiglia borghese dagli antichi splendori ma che versa in gravi difficoltà, sono nelle mani di un affarista, Leo Merumeci, tipico rappresentante del nuovo ceto dei ricchi, che vuole approfittare del loro stato di bisogno.
E' un film di carattere fortemente esistenziale, di una crisi esistenziale in cui l'angoscia, la colpa, la cattiva coscienza, la nausea, l'assurdo diventano allora i modi della sua rivelazione privilegiata.
L'accento è posto più su una condizione generale che non sulla storicizzazione della vicenda (cosa che gli fu rimproverata da molta critica di sinistra). E infatti la messa in scena non sottolinea gli aspetti dell'epoca, come avrebbero potuto fare per esempio Visconti o Bolognini; anche nei pochi esterni (il film si svolge quasi interamente nella villa avita) mancano gli elementi di riconoscibilità dell'epoca fascista (c'è una bellissima sequenza in cui Michele, Thomas Milian, cammina per le strade piovose, in cui la mdp è concentrata sul suo ppp e tutt'intorno è sfocato, indistinto). Eppure sappiamo in che epoca ci troviamo.
Unità di luogo, dunque e unità di tempo (il film si svolge nell'arco di due giorni).
Da sottolineare il ruolo della fotografia (direttore della fotografia, il grande Gianni Di Venanzo) al limite quasi della sottoesposizione per sottolineare un'atmosfera quasi mortuaria e il ruolo degli attori che sono una bellissima Claudia Cardinale, Rod Steiger, Paulette Goddard (attrice Chapliniana), Shelley Winters e Thomas Milian.
I miti della borghesia – onore, famiglia, amicizia, amore – i valori in cui essa credette nel periodo di massimo sviluppo sono infranti negli Indifferenti, svuotati, sminuiti al ruolo di falsa coscienza e di illusione. E' un mondo che scompare e un destino a cui non si può scampare: la dissoluzione della borghesia e l'avanzata di un nuovo ceto di ricchi. Ne sono consapevoli i due fratelli, i protagonisti. L'unica ancora di salvezza per loro risiede in una consapevole accettazione della propria sconfitta, nel fronteggiare il proprio declino, la propria impotenza con il freddo distacco degli Indifferenti, appunto.
L'ISOLA DI ARTURO di Damiano Damiani (1962)
L'isola di Arturo è il secondo romanzo di Elsa Morante del 1957 e tutti lo conosciamo, meno conosciuto credo il film che ad esso si è ispirato, realizzato da Damiano Damiani nel 1962 (lo stesso anno di Cronaca familiare, il film visto la scorsa settimana).
Damiano Damiani. autore anch'esso sconosciuto e dimenticato,
Regista, scenografo, pittore, sceneggiatore cinematografico, autore anche di documentari (Pasiano, Udine 1922 - Roma 2013). Agli esordi il suo cinema è stato attraversato da una speciale tensione etica e sociale, ereditata direttamente dal neorealismo, e successivamente, assecondando l'interesse per l'attualità italiana, la cronaca, ha adottato solidi schemi narrativi del cinema 'classico' statunitense, soprattutto quelli del genere poliziesco e noir, un po' come fece Pietro Germi.
Per Damiani il cinema non è solo espressione artistica, ma è anche un mezzo di denuncia sociale.
Girò spaghetti western come Quién sabe? (1967), ma fu soprattutto, come già detto, esponente del filone politico-civile con Il giorno della civetta (1968), tratto dall'omonimo romanzo di Leonardo Sciascia, Confessione di un commissario di polizia al procuratore della repubblica(1971).
Nel 1984 realizza la serie Tv La piovra la prima delle dieci, quella del commissario Cattani, interpretato da Michele Placido.
Nei primi film, comprensibilmente, si rivolse alla letteratura.
Nel 1962 realizza la sua prima trasposizione cinematografica di un'opera letteraria, con “L'isola di Arturo”, dall'omonimo romanzo di Elsa Morante, al 1963 risale “La noia”, trasposizione dell'omonimo romanzo di Alberto Moravia, sceneggiato con Tonino Guerra.
Film del '62, come Cronaca familiare che abbiamo visto la settimana scorsa, L'ìsola di Arturo ha una sceneggiatura a più mani, scritta dallo stesso regista con Ugo Liberatore ed Enrico Ribulsi, e la collaborazione di Cesare Zavattini.
E' un romanzo di formazione, quello che i tedeschi chiamano Bildungsroman, un genere letterario che si è andato affermando già a partire dalla fine del '700 e che ha trovato nel'800 il suo maggior sviluppo. Ma anche nel '900 esistono numerosissimi casi di di romanzi che raccontano dell'evoluzione e del passaggio del protagonista dall'età acerba dell'adolescenza a quella matura in cui si assiste al mutamento del rapporto del protagonista con il mondo circostante.
Arturo è il quindicenne orfano di madre, Arturo, che non è mai andato al di là di Procida, l'isola su cui è nato e cresciuto. Il rapporto col padre, il turbamento dell'amore, le prime rivelazioni dell'animo umano lo porteranno a maturazione e potrà dirsi pronto a lasciare l'isola.
Film non privo di difetti, ma di grande fascino, come vedrete.
Elsa Morante in più di un'occasione, trovò modo di manifestare il suo disaccordo per la scelta degli interpreti e per il taglio imposto ai caratteri. Dirà in un'intervista ad Andrea Barbato: «Il film che Damiani ha fatto dell'Isola di Arturo è bello, ma i personaggi sono cambiati. Il padre, ad esempio, è visto come un cattivo. Io invece non posso giudicare male i miei personaggi, ho bisogno di perdonarli prima di descriverli» (Barbato 1962). E lo stesso Damiani testimonierà: “La Morante non intervenne sulla sceneggiatura, la lesse, l'approvò, ricordo che non era molto d'accordo sulla protagonista perché aveva qualcosa di anglosassone – e difatti era americana – e l'avrebbe voluta più meridionale, anche meno bella. Probabilmente aveva ragione. Mentre giravamo, venne qualche volta a vedere le riprese, ma sempre con grandissima discrezione (Faldini / Fofi 1981: 160). Sino ad arrivare alle dichiarazioni inequivocabili che, un paio d'anni dopo, Elsa Morante rilascerà a Massimo D'Avack: Nessun scrittore può incolpare il regista di non restituire esattamente il libro nel film. Quello che si deve chiedere al regista è di non falsare volontariamente il significato ideologico e morale del libro [...], ma onestamente credo che fra me e lui [Damiani] ci sia un'enorme differenza nel modo di vedere il mondo e la vita. Sebbene Damiani non abbia assolutamente inteso essere infedele al libro, fatalmente è stato troppo infedele,
Questo non significa che io non apprezzi il film; ma esso ha un significato che non ha nulla a che vedere con quello del libro. Il film ha un significato moralistico che era quanto di più opposto al libro. [...]
MIYAZAKI
NEVER ENDING MAN. HAYAO MYAZAKI di Kaku Arakawa (2016)
Nel 2013 il maestro giapponese, dopo aver realizzato Si alza il vento che vedremo più tardi, annuncia il ritiro per raggiunti limiti di età. L'ha già fatto altre volte, ma come dice lui stesso “Questa volta, però, sono determinato: è una decisione definitiva”. Non lo sarà, e nemmeno la volta successiva. La sua forza immaginativa non è esaurita e ha bisogno di espandersi ancora. Lo seguiamo lungo il percorso, cosparso di entusiasmi e accidentato da dubbi e incertezze, che lo porterà verso nuove forme di creazione.
In particolare il confronto con le nuove tecniche di animazione, la computer graphic e la CGI, sarà la linea narrativa di questo film. Lui che ha sempre sostenuto la primazia del disegno a mano, si ritrova a vivere i diversi stati d'animo che gli si parano davanti in questo confronto con il nuovo, fatto di diffidenza, scetticismo, ma anche di attrazione, di curiosità e di caparbietà. La metafora del confronto vecchio/nuovo, della vita che va vissuta sempre, si dipana così in questo bel film che è un grande atto d'amore nei confronti di uno dei più grandi artisti del cinema d'animazione.
MYAZAKI: SI ALZA IL VENTO (2013)
Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. (Paul Valery). L'esergo del film ne racchiude il senso.
Si alza il vento, bisogna provare a vivere.
Dagli anni '20 alla seconda guerra mondiale, Jiro, il giovane eroe di questo grande affresco dipinto a mano, non sogna che di volare, ma la miopia che lo affligge gli impedisce di diventare pilota. La passione per gli aerei e il volo è così forte però che troverà un altro modo per manifestarsi. Sarà ingegnere aeronautico, inventore di formidabili aerei.
Per questo suo ultimo film Miyazaki ha preso dei rischi. Egli si avventura fuori dai territori del racconto, della fiaba, il suo territorio preferito, e imbastisce una storia che è una riflessione sul suo paese, le prove, le sofferenze e i compromessi di tutto un popolo.
Ma questa fresca storia non sarebbe così bella senza la sua dimensione intima. Miyazaki disegna il quotidiano con la delicatezza di un miniaturista. E mentre il mondo va in fumo, il nostro eroe si innamora.
Il personaggio di Jiro è un sognatore, un idealista, ma lontano dall'essere uno stravagante, un frivolo. Egli dà l'occasione a Miyazaki di costruire una storia delicata, dai piccoli tocchi narrativi, aneddoti e momenti scelti in una vita di cui non sono presenti che qualche istante.
Il romanticismo luminoso e tenero, gioioso e tragico, che prende il cammino di un racconto proustiano, dona al film il suo grande respiro. Un soffio fresco che fa volare i cappelli,i cuori e gli aerei di carta.
Un momento della storia reale in cui situare la vita di un sogno.
PADRE PADRONE di Paolo e Vittorio Taviani (1977)
Ispirato all'omonimo romanzo autobiografico di Gavino Ledda, Padre Padrone (1977) racconta la difficile, faticosa, improba emancipazione di un pastore sardo che, contro la volontà del padre gretto e violento, si dedica allo studio e diventa professore di glottologia.
Manifesto contro ogni forma di barbarie culturale e politica, questo film si può considerare il paradigma di un cinema didattico.
Il modello è vicinissimo all'ideale di cinema allora vagheggiato da Roberto Rossellini, peraltro presidente della giuria a Cannes nel '77 che gli conferì la Palma d'oro. Erano gli anni infatti in cui Roberto Rossellini con la sua produzione per la televisione stava realizzando il suo progetto di enciclopedia didattica audiovisiva, vale a dire lo sfruttamento delle risorse tecnologiche offerte dalla tv per diffondere la conoscenza (en passant, il film padre Padrone è prodotto proprio dalla Rai, ed è il primo caso di un film prodotto dall tv che vince a Cannes).
Ma il cinema di Rossellini, improntato a un realismo quasi naturale, è ben lontano da quello dei Taviani, in cui il realismo si nutre di artifici, di commistioni di forme espressive e di toni diversi, dove gli autori flirtano con il teatro, Brecht, il surrealismo, il lirismo e con le varie forme di nouveau cinéma.
Emblematica la sequenza iniziale: un uomo che intaglia un bastone, ci viene presentato come l'autore di un libro di successo da cui il film è tratto. L'uomo, che è evidentemente Gavino Ledda, l'autore appunto del libro, consegna il bastone al personaggio che ha il ruolo di suo padre affinché interpreti correttamente una scena della sua infanzia. L'inizio è in fondo una sorta di mise en abîme che racconta la storia di un romanziere che racconta la sua vita.
Ma il tono di astrazione o di quasi estraniamento brechtiano si prolunga anche in altri momenti del film.
Ma accanto a questo tono c'è un fondo più classico, per così dire. Per i Taviani l'infanzia è un tema importante e soprattutto molto serio. E questo tema si trova confrontato con un altro grande tema, come giù detto: la cultura come baluardo dell'infanzia contro la povertà, il destino o semplicemente contro la morte.
In questo senso il film è anche una plastica rappresentazione del complesso d'Edipo, il figlio che deve uccidere il padre per affermarsi come entità autonoma.
Tanti temi e motivi si intrecciano: il ritratto di una società arcaica, la Sardegna pastorale, il tema dell'educazione, del rapporto padre/figlio, del contrasto natura/cultura, l'emigrazione, la costruzione di una nazione attraverso le sue istituzioni.
E un film dalla complessità della costruzione. Una costruzione classica che sembra seguire lo sviluppo narrativo del libro a cui si ispira, ma, come detto, con continui ribaltamenti di tono. Una trama dura, violenta che però vira verso la pura poesia. Che passa da un realismo quasi documentario verso il lirismo dal forte impatto emozionale che coinvolgerà sicuramente noi spettatori.
LA RAGAZZA DI BUBE di Luigi Comencini (1964)
Per Luigi Comencini il cinema è un'arte dello spettacolo, cioè un'arte che non esiste senza il pubblico per il quale è stato concepito e realizzato. Da questo rispetto per il pubblico deriva che il regista è un artigiano prima ancora di un artista.
Se il principio fondamentale dello spettacolo è di non annoiare mai, Comencini ha senza sosta affinato un tono, un registro a mezza strada tra la commedia e il dramma in cui si mescolano, si oppongono o rimbalzano, dolore e malinconia, umorismo e ironia: un doppio sguardo, ironico e commosso (Comencini non ha paura dei sentimenti, pudore sì e anche delicatezza nel trattarli). Le grandi opere del cineasta si muovono sempre dentro questo registro: le situazioni più drammatiche possono prestarsi alla risata e i momenti grotteschi possono facilmente avere delle radici tragiche. (Tutti a casa è il primo film esemplificativo che mi viene in mente).
In quest'ottica la nozione di protagonista assume per Comencini un significato preciso: occorre che siano degli individui aventi dei precisi legami con la realtà quotidiana in cui il pubblico possa riconoscersi: “Affinché siano simpatici e il pubblico ne possa seguire con fiducia e interesse le avventure, occorre che siano dei poveri diavoli.” Questo interesse per i personaggi ordinari conduce Comencini a rifiutare la nozione di eroe come individuo fuori dal comune e a prendere in considerazione il mediocre che è portatore di una più grande verità umana. Così, ogni volta che ha potuto, Comencini ha scelto degli individui disarmati di fronte alla vita, e a questa galleria di personaggi appartiene pure Mara, la ragazza di Bube, Claudia Cardinale.
Comencini ha cominciato da subito a mettere l'Italia sullo schermo. Questa aspirazione a mettere l'Italia sullo schermo e a occuparsi dei problemi quotidiani delle persone diventerà un'attitudine costante del suo cinema. In un'opera vasta e varia questa preoccupazione di essere sempre presente ai suoi tempi è una sorta di fil rouge che percorre tutti i suoi film.
Così, di film in film, mai direttamente ma sempre mantenendo una maniera allusiva, Comencini disegna il ritratto di un'Italia che non è ovviamente quella di un economista o di un sociologo, ma di un artista che si esprime con i mezzi suoi propri, quelli della sensibilità rivolta verso individui mostrati nella loro dimensione singolare e nel loro significato collettivo.
E questo vale anche per La ragazza di Bube (1964) che esprime lo sforzo per immergersi in un passato recente, un passato che è il punto di partenza di una storia dell'Italia dove tutto si è giocato definitivamente, almeno così sembrava allora.
Il romanzo La ragazza di Bube fu il primo grande successo di Carlo Cassola quello che gli diede fama, notorietà e benessere economico. Vinse il Premio Strega del 1960 e nel 1965 inaugurò la serie degli autori italiani della neonata collana degli «Oscar» Mondadori. Carlo Cassola è un autore oggi del tutto dimenticato.
Comencini ne acquistò i diritti ancor prima che diventasse un best seller e lo realizzo solo nel '64, anche se già dall'assegnazione del Premio Strega nel '60 compariva l'immagine sorridente di Claudia Cardinale accanto a Cassola, forse una benaugurante promessa.
Il romanzo racconta la storia di una giovinetta, ispirata peraltro a un personaggio reale, Nada Giorgi, che diventa donna sacrificando molti anni della sua vita a un ex partigiano che è stato condannato per omicidio. Una tenera elegia sul tema della fedeltà alla parola data.
Con uno stile asciutto, terso e conciso trova un perfetto equilibrio fra storia privata e dramma collettivo nazionale.
Ma la ragazza di Bube non è un film sulla resistenza, ma sugli effetti della resistenza: la storia di un ragazzo che non capisce di essere stato coinvolto in un ingranaggio più grande di lui e ragiona su quello che gli è successo. Ma è soprattutto una storia d'amore, in cui prorompe la figura di Mara, una Claudia Cardinale forse mai così bella. Una grande eroina romantica di autentica umanità, che appartiene alla categoria degli umili che, come detto, sono quei personaggi che secondo Comencini sono i maggiori portatori di verità umana.
Comencini ci è particolarmente caro. Egli è stato il primo ad aver avvertito la necessità di salvare i film dalla distruzione e dunque la necessità della loro conservazione, al fine della diffusione della cultura cinematografica. E infatti fu tra i fondatori di una delle maggiori cineteche mondiali la Cineteca italiana e girò, tra i primi suoi film, un cortometraggio, Il museo dei sogni (1949), e il lungometraggio, La valigia dei sogni (1953), sua ideale prosecuzione, entrambi diretti a denunciare la pratica di macerare i film per recuperare il nitrato d'argento, la celluloide e altre sostanze e per sensibilizzare dunque l'opinione pubblica sulla salvaguardia dei film. Abbiamo pensato di proporvi il cortometraggio, il Museo dei sogni, dura solo 11', prima della visione della ragazza di Bube.
SAN MICHELE AVEVA UN GALLO (1973) di Paolo e Vittorio Taviani
Giulio Manieri è l'anarchico, utopista, idealista, che crede alla rivoluzione come sussulto spontaneo contro l'oppressione. Ma c'è una nuova generazione che pianifica, concerta, costruisce il futuro rivoluzionario a poco a poco.
Ispirato al racconto Il divino e l'umano di Lev Tolstoj, San Michele aveva un gallo (1973) rappresenta forse l'apice della carriera di Paolo e Vittorio Taviani (premiato a Berlino, li proietta in una dimensione internazionale) quantomeno per il modo in cui riesce a incarnare nel personaggio del sovversivo Giulio Manieri, interpretato da un eccellente Giulio Brogi, quell'eterno senso di sconfitta della sinistra rivoluzionaria che è stato sempre attuale – a parte brevi momenti della storia – e che lo è ancora di più oggi, dove il senso della disfatta del comunismo – e della sinistra in genere – ha assunto delle proporzioni abissali.
La crisi e il riflusso dell'istanza rivoluzionaria sono il tema centrale del film e saranno anche il tema del successivo Allonsanfan.
Nel film i conflitti ideologici contemporanei sono calati in una cornice metastorica. San Michele aveva un gallo reinterpreta infatti temi dell'anarchismo utopistico ottocentesco con occhi chiaramente rivolti alla temperie della contestazione generale sessantottesca. Ma i suoi contenuti ideologici appaiono distesi in una forma narrativa felice che ha la struttura di una partitura musicale in tre tempi che richiama la tradizione del melodramma italiano. E vengono rappresentati con armonia e partecipazione alle umane sofferenze del protagonista ammalato di solitudine e serenità espressiva che fanno di questo film un classico.
San Michele aveva un gallo, dicevamo, ha una struttura esattamente tripartita lungo i 90 minuti della sua durata: una prima mezz'ora dedicata alla fallita azione di Manieri e del suo gruppo e alla sua condanna a morte poi commutata in ergastolo all'ultimo momento; una seconda mezz'ora incentrata sulla prigionia di Manieri; una terza sul suo incontro/scontro nella laguna veneta con i nuovi rivoluzionari che lo disprezzano e lo gettano nello sconforto.
STORIA IMMORTALE di Orson Welles (1968)
Questo sontuoso racconto ha visto la luce grazie alla televisione francese che glielo commissionò quando Orson Welles annaspava nella preparazione del Don Chisciotte.
Un ricco mercante si ricorda di una storia che gli ha raccontato un marinaio: un vecchio paga profumatamente un marinaio incontrato per la strada affinché giaccia con la moglie perché gli dia un erede. Quando il suo segretario gli conferma che in realtà si tratta di una storia che tutti i marinai del mondo raccontano, il ricco mercante decide di mettere in scena questa storia perché divenga autentica: “Se questa storia non è mai accaduta, io la farò accadere...”
Storia immortale è adattato da un racconto di Karen Blixen che Welles ammirava molto, e in cui si ritrovano i temi più cari a Welles che in poco meno di un'ora impartisce una lezione di arte, di letteratura, di cinema ed è una conferma del solito discorso wellesiano che il potere è pesante da reggere e che inevitabilmente tende a sopraffarti.
Si tratta del primo film a colori di Orson Welles. Il film è breve , ma la storia è molto ricca, dalle molte sfaccettature e assai evocatrice. E' una riflessione sulla menzogna della messa in scena, sul rapporto tra l'arte e la realtà, sulla giovinezza perduta, sul passato reale o immaginario che si fa rivivere, sul passato che si vuol far rivivere e quello che che si è vissuto. La storia si sviluppa nel 19 secolo nella colonia portoghese di Macao ma non è connotata temporalmente.
Conciso, spoglio, il film afferma che la bellezza può nascere da un sentimento negativo: il potente che mette in scena un simulacro d'amore solo per verificare la portata del suo potere.
Un'affermazione che pervade tutta l'opera di Orson Welles, da Citizen Kane a Mr. Arkadin, l'autore si riserva immancabilmente il ruolo del tiranno pigmaglione.
Vi si trova una delle più belle scene d'amore mai filmate.
LO STRANIERO di Luchino Visconti (1967)
Tratto dall'omonimo libro di Albert Camus del 1942.
Un libro dalla natura molto particolare. Che può essere considerato un romanzo e l'enunciazione di una filosofia. E che può essere letto tanto in chiave storico-realistica che simbolico-psicologica.
Algeri 1935. Mersault, modesto impiegato, apparentemente insensibile, conduce una vita abbastanza monotona. Quando muore sua madre non manifesta alcuna emozione. Tutto sembra lasciarlo indifferente: la relazione con la sua collega Marie (una Anna Karina icona della Nouvelle Vague), la promozione propostagli dal direttore. Persino un assassinio non premeditato.
Meursault appartiene alla schiera degli eroi camusiani, che, come dirà Sartre commentando il testo di Camus, “non sono né buoni, né cattivi, né morali né immorali. Queste categorie non gli appartengono: egli fa parte di una specie assai singolare alla quale Camus riserva il nome di assurdo.”
“L'assurdo è uno stato di fatto, come un dato originario. Niente di meno che il rapporto con il mondo. La morte, il pluralismo irriducibile delle verità e degli esseri, l'initelligibilità del reale, il caso: sono questi i poli dell'assurdo - conclude Sartre, che pure di eroi dell'esistenzialismo se ne intendeva -, capaci di rendere epico il loro fallimento, la propria sconfitta valorosa nella lotta contro l'orrore della vita moderna.”
Visconti aveva letto e amato il libro fin dalla sua nascita, nel clima inquieto dell'esistenzialismo e aveva cominciato a lavorare al progetto di trasposizione cinematografica già dal '62, all'indomani della indipendenza algerina, che nuova linfa interpretativa poteva dare a quel suo amore. Poi il progetto si interruppe e fu ripreso solo nel 1967, epoca in cui gli echi dei nascenti fenomeni di contestazione giovanile sembravano una nuova manifestazione di quel malessere e di quelle aspirazioni di libertà che la sua generazione aveva riconosciuto nell'assurdo camusiano.
Ma tutte le suggestioni di infondere al film una libertà interpretativa del testo di Camus si infransero dapprima contro l'intenzione di voler però rifuggire da ogni arbitrio interpretativo e poi contro i veti della vedova di Camus, Francine, che aveva vincolato la concessione dei diritti alla fedeltà al testo.
E così fu, Visconti si decise a mantenersi fedele al testo.
Ora, come rendere visivamente quel senso di assurdità perfettamente naturale e verosimile che sprigiona dalle pagine di Camus, non facili da rappresentare?
Visconti distanzia la prospettiva degli eventi grazie ad un uso eccellente della voce off, grazie all'uso del campo lungo e lunghissimo. Imposta realisticamente le scene, ma le riprende da prospettive non naturalistiche; o ancora grazie alla recitazione di Mastroianni che interpreta il protagonista che sottolinea la condizione squallida e priva di realtà. E tutto contribuisce a delineare l'ambiguo confine tra verità e apparenza: “qui tutto è vero e niente è vero”, dirà nel corso del processo l'avvocato difensore.
Visconti, con la collaborazione alla sceneggiatura di Suso Cecchi D'Amico – grande specialista negli adattamenti di opere letterarie, ha certo proposto una lettura limitata del romanzo di Camus, ma ne ha fornito una illustrazione rigorosa e assai sensibile.
STRATEGIA DEL RAGNO (1970)
Il film di stasera è La strategia del ragno, quarto film di Bertolucci girato in stato di grazia nel 1969, liberamente ispirato al racconto di Borges, Tema del traditore e dell'eroe, che fa parte della raccolta Finzioni.
Il film vede insieme Bernardo Bertolucci e Giulio Brogi scomparsi da poco, a poca distanza l'uno dall'altro. La proiezione di questa sera assume dunque anche il significato di omaggio ai due artisti.
Athos Magnani ritorna alla sua città natale, Tara, un nome di fantasia, in realtà il luogo reale è Sabbioneta, cittadina vicino Mantova, che come molte città d'arte italiane, è sostanzialmente uno spazio di rappresentazione, un teatro all'aperto. Athos Magnani è il figlio di un eroe dal suo stesso nome, un militante politico assassinato dai fascisti, morto quando lui aveva appena un anno, e in onore del quale è stata eretta una statua. Sulla targa della statua è detto che sono state le camicie nere ad assassinarlo, ma non il nome di chi ha premuto il grilletto. Il giovane uomo vuole scoprire questo. E inizia la sua investigazione alla simbolica ricerca del padre. Quando questo itinerario sarà compiuto prevarrà la consapevolezza che la verità vale sempre più del mito.
Realizzato per la Rai, si tratta di un'opera che presenta una varietà' e ricchezza di piani di lettura, come è ricorrente nei film di Bertolucci. Il primo di essi e' costituito proprio dalla riflessione sul mito e sulla sua utilizzazione nel creare la cultura di un popolo e la memoria collettiva. La morte del padre costituisce ormai un elemento fondante della cultura collettiva di una intera comunità e non si può' distruggere.
Il secondo piano di lettura è quello psicoanalitico e riguarda i rapporti tra Athos figlio e la figura ingombrante del padre-eroe che schiaccia la sua personalità (entrambi interpretati da Giulio Brogi) e lo tiene avviluppato in quella fitta ragnatela di condizionamenti del passato che ci impediscono di essere veramente noi stessi. Dirà Bertolucci stesso che “Tara rappresenta la rinuncia a Parma (sua città natale), per il bisogno di condannare la cultura del padre”. Ma non si fugge il proprio passato, sembra voler dire Bertolucci, con esso bisogna fare i conti, se si vuole veramente rivelare a se stessi la propria identità.
Filmato con ampi movimenti di macchina, i paesaggi della pianura padana e i monumenti di Sabbioneta spuntano agli occhi dello spettatore con colori inquieti e strani tra il verde del fogliame e il blu acquerello dell'atmosfera ( da notare che la forografia è di Vittorio Storaro che proprio con questo film comincia la lunghissima collaborazione con Bertolucci). Questa città in cui la geometria prevale sulla geografia assomiglia, nel film di Bertolucci, a una collezione di quadri di De Chirico o di Magritte. Il cineasta dice di aver girato in uno stato di trance prossimo al sogno.
Ritmato da flashback che costituiscono quasi i fili di una complessa tela del ragno che avviluppano il protagonista, il film di Bertolucci si costruisce sulla geometria rettilinea ed enigmatica di Sabbioneta.
Dicevamo che Bertolucci imposta il film come una investigazione e in realtà manterrà la suspense fino alla fine, senza però creare quello stato d'angoscia proprio del thriller. Egli infatti si diverte a tessere la sua strategia del ragno in cui avvolgere lo spettatore entro la fitta trama di citazioni e rimandi: all'opera, alla letteratura, alla storia.
Rigoletto è utilizzato come un canto funebre. Come il più tipico melodramma operistico, l'assassinio è reso grandioso e adattato all'opera verdiana: dopo che viene gridato “Maledizione” da Rigoletto il tiratore può agire indisturbato, protetto dall'applauso della folla. (Chi l'ha visto, ricorderà che anche in Prima della rivoluzione, un momento topico della vicenda si svolge in un teatro dell'opera e sempre con Verdi, quella volta però con il Macbeth.) Bertolucci invita altri personaggi storici ad unirsi alla festa. Il nome del protagonista richiama il moschettiere di Alexandre Dumas. Oppure la lettera che preannuncia la morte, come nel dramma Giulio Cesare di Shakespeare e ancora Shakespeare con Macbeth, con la lettura della mano che preannuncia un oscuro destino. Dreifa, l'amante del padre (Alida Valli), deriva da Dreyfuss, di cui suo padre si era infatuato.
Come si vede, per certi versi, il cinema di Bertolucci, è un'arte barocca, che deve riempire tutti i vuoti. Con tanti piani sequenza che paradossalmente rafforzano la teatralità delle situazioni. C'è insomma sempre in Bertolucci dell'artificio dentro il realismo. La stilizzazione plastica e spaziale ridefinisce, in maniera singolare, la nozione di modernità cinematografica.
Strategia del ragno, come detto, mescola passato e presente, amici e nemici, tradimento ed eroismo, sucitando la curiosità e l'attaccamento verso questo giovane bruno dagli occhi blu alla ricerca delle sue radici.
LA VIACCIA di Mauro Bolognini (1961)
Autore di più di 40 film, Bolognini occupa un posto centrale nel cinema italiano che contribuisce a rinnovare tra la fine degli anni '50 e inizio anni '80. E' stato un regista particolarmente attento alla coerenza formale e alla precisione stilistica ma anche allo scavo psicologico e alla dialettica dei conflitti sociali.
Fu dotato di un acuto senso dell'immagine, di grande abiltà a ricreare le atmosfere del passato, e con una certa predilezione per le storie passionali dalle forti connotazioni melodrammatiche.
Decisivo fu l'incontro con Pasolini soggettista e sceneggiatore dei suoi primi film come La notte brava, 1959, e La giornata balorda, 1960, che ci proiettano già nell'universo letterario di Ragazzi di vita e costituiscono un'anticipazione dei film successivi di Pasolini.
Mauro Bolognini nella sua attività di cineasta si è molto spesso ispirato alla letteratura, trasponendo sullo schermo tantissimi autori del Novecento tra cui V. Pratolini (Metello), V. Brancati (Il bell'Antonio, che vedremo nella nostra rassegna) e soprattutto A. Moravia (Agostino, Gli indifferenti, serie televisiva, La villa del venerdì, La giornata balorda già citato).
Ma dicevamo dell'accuratezza formale e della precisione stilistica di Bolognini.
La viaccia (1961), dal romanzo L'eredità del toscano M. Pratesi, alla cui sceneggiatura collaborò Pratolini, può essere considerato una delle prove più raffinate di B. per la ricostruzione d'ambiente, una fine Ottocento esaltata dalla fotografia sempre in bianco e nero di Leonida Barboni e dai costumi di Piero Tosi, e per protagonista una giovane, ardente Claudia Cardinale. Il film trovò, nella qualità visiva, nel montaggio e per la prova dell'attrice, una drammaticità e una inquietudine esistenziale da farne l'esempio di come un romanzo possa specchiarsi in un efficace corrispettivo cinematografico del tutto autonomo e insieme parallelo.
Alla morte del nonno, Amerigo (Jen-Paul Belmondo) si reca a Firenze per lavorare presso uno zio vinaio da cui il padre spera di ottenere in eredità il podere chiamato La Viaccia. Qui incontra Bianca, una prostituta e se ne innamora (un'altra splendida Claudia Cardinale, dopo quella della settimana scorsa, di una bellezza che neanche i pizzi e i corsetti di fine ottocento riescono a contenere).
Bolognini ha ambientato questa storia tipicamente verista in una Firenze della fine Ottocento, nebbiosa, grigia, malinconica, spenta. Fa da contrasto con questi sfondi urbani una casa di piacere piena di oggetti sontuosi, pesanti, mobili, arredamenti, decorazioni, una casa di piacere degna forse di Toulouse Lautrec o Degas. Si capisce il peso del gusto figurativo di Bolognini, che è sempre stata una costante del suo cinema. Ma sarebbe limitativo ridurre il film a quest'aspetto che pure è preponderante. Importante è sottolineare invece la modernità che Bolognini imprime al romanzo dell'Ottocento, ponendo al centro della vicenda la figura di Amerigo, che non è un personaggio dell'ottocento bensì moderno: disinteressato, e ambiguo, con un forte tormento esistenziale.
E altro elemento di modernità rispetto al romanzo è la riflessione di una realtà contadina, di una chiusa, disperante avarizia, la riflessione su un mondo definito dall'aridità dei sentimenti, tipico di una storia d'Italia, che chissà se si sia mai conclusa.
Piccola bibliografia di riferimento:
Elio Petri appunti su un autore, a cura di Paola Petri, La Biennale Venezia, 2007
Ingmar Bergman, Sergio Trasatti, Il Castoro, 2011
Bernardo Bertolucci, Stefano Socci, Il Castoro, 2008
Storia del cinema mondiale, a cura di Gian Piero Brunetta, Einaudi, 2000
I volti e le mani - Il cinema di Ermanno Olmi, a cura di Benedetta Tobagi, Feltrinelli, 2008
Tutti i film di Federico Fellini, Enrico Giacovelli, Lindau, 2002
Il film sessanta- Il cinema degli anni 1962-1966, Tullio Kezich, Il Formichiere, 1979
Ermanno Olmi - Il mestiere delle immagini, diario in pubblico di un'amicizia, Tullio Kezich, Falsopiano, 2004
Elio Petri appunti su un autore, a cura di Paola Petri, La Biennale Venezia, 2007
Ingmar Bergman, Sergio Trasatti, Il Castoro, 2011
Bernardo Bertolucci, Stefano Socci, Il Castoro, 2008
Storia del cinema mondiale, a cura di Gian Piero Brunetta, Einaudi, 2000
I volti e le mani - Il cinema di Ermanno Olmi, a cura di Benedetta Tobagi, Feltrinelli, 2008
Tutti i film di Federico Fellini, Enrico Giacovelli, Lindau, 2002
Il film sessanta- Il cinema degli anni 1962-1966, Tullio Kezich, Il Formichiere, 1979
Ermanno Olmi - Il mestiere delle immagini, diario in pubblico di un'amicizia, Tullio Kezich, Falsopiano, 2004
News pubblicata martedì 21 maggio 2019